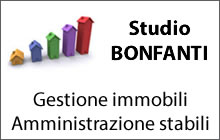Il ruolo delle donne nella Chiesa: questione di ordine non di genere

Il tema del ruolo delle donne nella Chiesa è certamente centrale e credo essenziale nel dibattito odierno ecclesiale, come ben evidenziato dagli articoli citati sia da me sia dal Sig. Colombo. La recente nomina della/ del Prefetta/o di un Dicastero ha suscitato una discussione interessante, che riguarda non solo su una possibilità di modificare una norma canonica ma di cambiare completamente approccio, soprattutto in chiave sacramentale. Nel primo mio scritto non ne ho criticato la scelta, solo le modalità. Andrea Grillo, con cui stranamente mi trovo d’accordo, solleva un nodo giuridico centrale: la certezza del diritto nell’ordinamento canonico, come in una comune società. Se un prefetto non è ordinato e il diritto canonico prevede che chi detiene la potestà di governo debba essere un chierico, allora si pone un problema normativo. Su questo punto, il dibattito è necessario. Il problema non è tanto il sesso, quanto l’ordine. Una nomina di governo anche fatta a un uomo, non ordinato, ci porrebbe nella stessa situazione giuridica. Diverso è il caso dell’argomentazione di Donata Horak. La teologa muove dalla premessa che il battesimo conferisce a tutti i fedeli, uomini e donne, la stessa dignità e il medesimo inserimento nel Popolo di Dio, e da ciò deduce che non esistono motivazioni teologiche valide per escludere le donne da ruoli di leadership e ministero. La sua impostazione presenta un grave errore di fondo: confonde il sacerdozio comune dei fedeli, acquisito con il Battesimo, con il sacerdozio ministeriale, acquisito con l’Ordine Sacro. Sono due realtà ben distinte secondo il Magistero della Chiesa. La Lumen Gentium, al n. 10, afferma chiaramente che il sacerdozio battesimale e quello ministeriale “differiscono essenzialmente e non solo di grado”. Tutti i battezzati partecipano al sacerdozio di Cristo, ma solo alcuni ricevono, attraverso il sacramento dell’Ordine, una configurazione speciale a Cristo Capo e Pastore della Chiesa. Questo non è un limite posto dal Diritto della Chiesa, ma una realtà teologica fondata sulla volontà stessa di Cristo, a cui il diritto si rifà. L'argomento di Horak, dunque, non tiene conto di questa distinzione fondamentale e genera confusione.
Alla luce del Concilio, quindi, non si tratta di discriminazione di genere, ma di una diversità di ruoli e vocazioni all’interno della Chiesa. Se il battesimo fosse sufficiente per accedere a ogni ministero ecclesiale, allora non sarebbe più necessario il sacramento dell’Ordine Sacro. La Chiesa riconosce pienamente il contributo delle donne alla vita ecclesiale e, come afferma Praedicate Evangelium, il loro coinvolgimento nei ruoli di governo è imprescindibile. Ad oggi però tale partecipazione non implica una ridefinizione del ministero ordinato.
A tal proposito, è utile fare un riferimento storico alla questione delle diaconesse nella Chiesa primitiva, di cui ho già leggermente trattato. Spesso si cita la figura di Febe, menzionata da San Paolo nella Lettera ai Romani (16,1), come “diaconessa della Chiesa di Cencre”. Tuttavia, il termine diacono (dal greco diakonos, “servitore”) non implicava in origine un ruolo gerarchico definito come lo intendiamo oggi, anche perché la struttura ecclesiale era in via di sviluppo. Le diaconesse si occupavano principalmente della cura dei malati, dei poveri e dell’assistenza agli apostoli. Il loro servizio era fondamentale anche per il battesimo delle donne, che avveniva per immersione totale, preservandone la decenza e la modestia.
Giovanni Crisostomo elogia il ruolo delle diaconesse, citando in particolare Olimpia, una vedova che dedicò la sua vita e le sue risorse alla Chiesa. Nei suoi Commentari alle Epistole di San Paolo, sottolinea l'importanza del loro servizio caritativo e della loro funzione di insegnamento alle donne e ai bambini. Tuttavia, è evidente che il loro ruolo non era assimilabile a quello dei diaconi ordinati, né si inseriva in una gerarchia sacramentale.
Ovvio, sono ben cosciente che il diaconato nella chiesa delle origini non era come lo intendiamo oggi, perché era un servizio più che un ordine, e il mio parallelismo è una esagerazione teologica. Contro questa mia tesi del diaconato alle donne il teologo Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ribadisce che il diaconato è parte integrante del sacramento dell’Ordine è che la Chiesa ha circoscritto definitivamente che solo gli uomini possono ricevere il sacramento dell'Ordine (come affermato da Ordinatio Sacerdotalis di San Giovanni Paolo II nel 1994), anche il diaconato non può essere conferito alle donne. Anche Hauke, mariologo e dottore in sacramentaria, spiega che il diaconato femminile non ha alcuna base sacramentale. Hauke continua sostenendo che la Lumen Gentium chiarisce che il sacramento dell’Ordine è riservato agli uomini perché essi rappresentano sacramentalmente Cristo, Capo della Chiesa. L’introduzione di un diaconato femminile minerebbe questa struttura simbolica e teologica.
Ritengo, quindi, che la vera rivoluzione inizia dal basso, dal diaconato alle donne. E la svolta dovrebbe passare non solo per la pastorale ma anche per la sacramentaria. Anche la riforma liturgica ha avuto un lento ma decisivo imprinting nella Chiesa ma è iniziata molto prima del Concilio, con la riforma di Pio XII e la Commissione Liturgica. In primis si inseriva in un contesto di sviluppo organico della liturgia, dal basso, che ha portato solo dopo decenni a un radicale cambiamento non solo della lingua ma dell’impianto stesso della Celebrazione Eucaristica, con il rito di Paolo VI. Quel cambiamento, che oggi a noi pare ovvio, è nato da forti dibattiti e anche, ahimè, da polarizzazioni, oggi ancora vive, fuori dall’Ovile della Chiesa Cattolica, come la nascita della Fraternità di Pio X di Mons. Lefebvre.
La vera questione centrale è se e come garantire una maggiore partecipazione femminile in senso organico senza snaturare la struttura sacramentale della Chiesa. Ad oggi io non saprei ben definire come. Bisognerebbe dimostrare che l'ordinazione delle diaconesse avveniva con un rito simile a quello dei diaconi uomini. O almeno bisognerebbe chiarire come la Chiesa potrebbe risolvere questa questione senza contraddire la teologia sacramentale. È su questo terreno che la riflessione teologica, e successivamente quella giuridica, deve muoversi con attenzione. In tal senso, il ruolo del teologo e del divulgatore è proprio quello di fare chiarezza, evitando semplificazioni e spiegando la coerenza della Tradizione con le esigenze pastorali del presente. Il Magistero precede la Teologia in quanto espressione dell’autorità della Chiesa, ma la Teologia ha il compito di approfondire e interpretare le questioni in modo costruttivo, offrendo strumenti di comprensione più ampi e fondati. Il dibattito resta aperto, ma deve essere condotto con rigore, senza cedere a letture riduttive o a forzature ideologiche. Il progresso nella Chiesa non si realizza alterando la sua natura, ma approfondendo sempre meglio il senso autentico della sua missione.
Pietro Santoro