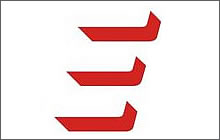Imbersago: Roberto Slamitz, figlio di esuli istriani, nato in un centro raccolta profughi racconta la sua 'risalita' fatta di sacrifici
Roberto Slamitz ha 68 anni, dal 2002 vive ad Imbersago e gran parte della sua vita l'ha trascorsa lavorando per gli ospedali di mezzo mondo ai quali forniva impianti di radiologia. Una vita tutto sommato normale, magari, a seconda dei gusti, un po' più emozionante di altre, piena e serena, se solo non fosse per quei ricordi di infanzia legati alla sua condizione di profugo, figlio di genitori originari della Dalmazia, costretti a fuggire dall'eccidio delle foibe voluto dal regime di Tito.
Dunque, da bambino tu sei stato vittima di una vendetta bellico-politica?
In un certo senso, il terribile eccidio delle foibe si può considerare una vendetta, o ritorsione. La Dalmazia è sempre stata italiana, fin dall'Impero Romano. Al di là di quelle che sono le appartenenze geografiche in base ai confini, in quelle terre si è sempre parlato l'italiano. Poi vennero Napoleone e successivamente l'Italia cedette all'Austria quella lingua di terra, mandandovi ad abitare la gente comune, come i miei avi, e non come si racconta di solito, gli esponenti borghesi e aristocratici. Così i fascisti, per riprendersela, utilizzarono dei metodi atroci. Quando si parla dei campi di concentramento, a nessuno vengono in mente quelli organizzati dai fascisti in quella regione, dove vennero sterminati migliaia di poveri croati. Per questo, la conseguenza è stata che il comunismo slavo, una volta terminata la guerra, ha utilizzato metodi altrettanto terribili per riprendersi quel territorio. Si tratta di fatti insabbiati per troppo tempo, comunque, portati alla luce solo da qualche anno.
Puoi raccontarli attraverso la tua esperienza personale. Ad esempio, come riuscirono a sopravvivere i tuoi genitori, originari della Dalmazia?
Semplicemente fuggendo. Nel '45 arrivarono a Fiume i comunisti di Tito. Mia madre, Maria Godetz, insieme a sua sorella, presero a lavare la biancheria dei soldati comunisti in cambio di cibo, era un periodo di povertà estrema dopo la guerra. Nel novembre dello stesso anno, quando mia mamma aveva 18 anni, un capitano dell'esercito croato, vedovo, le si avvicinò convinto che l'avrebbe sposata. Al suo rifiuto, il capitano la minacciò con una pistola, e lei si chiuse in casa. Incontrò di nuovo quel militare qualche giorno dopo, quando la polizia la portò da lui, il quale si scusò, ubriaco, per il suo comportamento. Scappò da Fiume, insieme a mia nonna e mia zia, nel '46 perché voleva rimanere italiana. Riuscì ad ottenere un permesso speciale per andare a Trieste a comprare del cibo, ma poi non tornò più. Finirono nel campo rifugiati di quella città, dove subirono l'umiliazione della disinfestazione. Vennero trasferite in diversi campi profughi, a Udine, a Milano, a Roma e a Verona, dove mia mamma incontrò Francesco Slamitz, mio padre, contrario ai fascisti dai quali era stato anche ferito con un proiettile, già in Italia da tempo sull'Appennino toscano dove si era dato alla macchia perché non voleva andare a combattere per i tedeschi.
Dove incomincia, invece, la tua storia?
Sono nato nel '49 all'interno del centro di raccolta profughi a Marina di Massa, in Toscana, dove i miei genitori si erano trasferiti l'anno prima. Siamo rimasti in quel campo fino al '52. Mio padre lavorava come pescatore, si viveva nella povertà più estrema insieme ad altri 700 esuli dalmati. Le famiglie vivevano in stanzoni con camere divise dalle coperte militari, i più fortunati avevano a disposizione una brandina, gli altri dormivano su dei pagliericci per terra. Dopo tre anni fummo trasferiti nel centro di raccolta profughi nella Villa Reale di Monza.
Quali sono i ricordi più lucidi che ancora conservi?
Diversi, si viveva nell'indigenza e di giochi non se ne avevano, ovviamente. Ricordo però, che utilizzavo le parti di una valigia di cartone, che conservo ancora oggi, come se fossero dei mattoncini dei lego. Nonostante la condizione difficile, i nostri genitori ci insegnarono a vivere con diligenza, ma una volta ruppi una finestra con una fionda e venni rimproverato. Un altro ricordo legato a Carrara è di quando mio padre tornava dal lavoro, prendevo alcune sardine appena pescate, le sciacquavo nel mare mangiandole crude. A metà gennaio, sono tornato nella Villa Reale di Monza. Oggi, nella stalla dove eravamo "ospitati", ci sono le aule degli studenti del liceo artistico. Mi ha fatto un certo effetto vedere molte cose, soprattutto lo scalone di un'ala dell'edificio in cui mia madre mi aveva proibito di andare.
Come cambiò la tua vita quando riusciste ad uscire dal centro di profughi di Monza?
Avevo 6 anni, l'anno preciso in cui potevo incominciare la scuola. Mio padre riuscì per la prima volta a guadagnare abbastanza per pagare un affitto. Poi i miei genitori presero in gestione per qualche anno un circolo Acli, in cui davo una mano anche io. Dei primi anni di scuola ricordo l'imbarazzo che si provava a portare un cognome austriaco, ma con il tempo la cosa è passata e, una volta ottenuta una stabilità economica migliore (visto che a pesare era soprattutto la condizione di povertà rispetto agli altro) tutto si è ristabilito. Ho sempre fatto alternanza scuola-lavoro in pratica (Slamitz incontrerà a breve gli alunni dell'Istituto Agnesi di Merate proprio per parlare di questo argomento, ndr). Finite le scuole dell'obbligo, invece, mi chiamarono per lavorare alla Pirelli. Decisi che avrei lavorato senza però poter smettere di studiare, così mi iscrissi alle scuole serali. Da quando mi sono diplomato ho svolto diversi lavori, fu grazie ad un mio compagno di squadra, perché ho sempre giocato a calcio, che entrai nel mondo della radiologia. Nella mia carriera ho visitato tanti paesi del mondo, sono stato tecnico e dirigente per una grande multinazionale, ho perso il lavoro per alcune vicissitudini e, rimboccandomi le mani, mi sono rimesso a fare manutenzioni in giro per il mondo. Alcuni di ragazzi di oggi non li capisco, pretendono di trovare lavoro sotto casa e alle migliori condizioni. Consiglio sempre due cose: di prendersi meno sul serio e “fare sacrifici” , che un lavoro si trova.
Trovi delle analogie, infine, tra la tua condizione di profugo, di quando eri appena un bambino, rispetto a quella che vivono i profughi dei nostri giorni?
Decisamente poche. Sono stato volontario della Protezione civile, mi è capitato di accompagnare alcuni rifugiati in una cascina della bergamasca. Per quanto posso raccontare, i rifugiati con cui ho avuto a che fare non hanno fatto altro che lamentarsi per tutto il tempo, non andavano bene le vivande che gli erano state consegnate, volevano poter chiamare i loro famigliari quanto prima, anche se non era ancora possibile. Io non sono contro l'accoglienza, ma questi profughi hanno troppe pretese. Nel nostro caso, ci si accontentava di quello che si aveva, lo Stato dava 100 lire per ogni componente della famiglia, 125 per il capofamiglia. Si viveva con quello, e il più lo si poteva guadagnare lavorando. Allora, le persone non ti giudicavano, non abbiamo mai sofferto per delle discriminazioni.

Roberto Slamitz
Ricordi di una guerra passata con tutte le sue conseguenze, di miseria e di povertà, che Slamitz racconterà anche venerdì 10 febbraio, giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, alle 21, durante la serata organizzata dall'Amministrazione in Municipio. Roberto aveva 6 anni quando, per la prima volta, lui e la sua famiglia poterono finalmente considerarsi liberi e indipendenti, lontani da quel centro di raccolta profughi di Monza, situato nelle stalle della Villa Reale, dal quale lui e la sua famiglia se ne andarono solamente quando papà Francesco Slamitz, cognome austro-ungarico, trovò un lavoro stabile. Oggi Slamitz è un atletico pensionato - ha appeso le scarpette da calcio appena due anni fa, ma solo perché la sua squadra si è sciolta, mentre in gioventù era stato un brillante atleta del salto in alto e lancio del disco - allegro e sorridente, colto a sufficienza per giudicare le vicende storiche di cui è stato vittima, inconsapevole, quando è stato bambino come "una ritorsione, da parte dei comunisti, alle atrocità fasciste che vennero combinate in Slovenia e Croazia".
I fratelli Eleonora e Roberto Slamitz
Dunque, da bambino tu sei stato vittima di una vendetta bellico-politica?
In un certo senso, il terribile eccidio delle foibe si può considerare una vendetta, o ritorsione. La Dalmazia è sempre stata italiana, fin dall'Impero Romano. Al di là di quelle che sono le appartenenze geografiche in base ai confini, in quelle terre si è sempre parlato l'italiano. Poi vennero Napoleone e successivamente l'Italia cedette all'Austria quella lingua di terra, mandandovi ad abitare la gente comune, come i miei avi, e non come si racconta di solito, gli esponenti borghesi e aristocratici. Così i fascisti, per riprendersela, utilizzarono dei metodi atroci. Quando si parla dei campi di concentramento, a nessuno vengono in mente quelli organizzati dai fascisti in quella regione, dove vennero sterminati migliaia di poveri croati. Per questo, la conseguenza è stata che il comunismo slavo, una volta terminata la guerra, ha utilizzato metodi altrettanto terribili per riprendersi quel territorio. Si tratta di fatti insabbiati per troppo tempo, comunque, portati alla luce solo da qualche anno.
Puoi raccontarli attraverso la tua esperienza personale. Ad esempio, come riuscirono a sopravvivere i tuoi genitori, originari della Dalmazia?
Semplicemente fuggendo. Nel '45 arrivarono a Fiume i comunisti di Tito. Mia madre, Maria Godetz, insieme a sua sorella, presero a lavare la biancheria dei soldati comunisti in cambio di cibo, era un periodo di povertà estrema dopo la guerra. Nel novembre dello stesso anno, quando mia mamma aveva 18 anni, un capitano dell'esercito croato, vedovo, le si avvicinò convinto che l'avrebbe sposata. Al suo rifiuto, il capitano la minacciò con una pistola, e lei si chiuse in casa. Incontrò di nuovo quel militare qualche giorno dopo, quando la polizia la portò da lui, il quale si scusò, ubriaco, per il suo comportamento. Scappò da Fiume, insieme a mia nonna e mia zia, nel '46 perché voleva rimanere italiana. Riuscì ad ottenere un permesso speciale per andare a Trieste a comprare del cibo, ma poi non tornò più. Finirono nel campo rifugiati di quella città, dove subirono l'umiliazione della disinfestazione. Vennero trasferite in diversi campi profughi, a Udine, a Milano, a Roma e a Verona, dove mia mamma incontrò Francesco Slamitz, mio padre, contrario ai fascisti dai quali era stato anche ferito con un proiettile, già in Italia da tempo sull'Appennino toscano dove si era dato alla macchia perché non voleva andare a combattere per i tedeschi.

Francesco Slamitz
Dove incomincia, invece, la tua storia?
Sono nato nel '49 all'interno del centro di raccolta profughi a Marina di Massa, in Toscana, dove i miei genitori si erano trasferiti l'anno prima. Siamo rimasti in quel campo fino al '52. Mio padre lavorava come pescatore, si viveva nella povertà più estrema insieme ad altri 700 esuli dalmati. Le famiglie vivevano in stanzoni con camere divise dalle coperte militari, i più fortunati avevano a disposizione una brandina, gli altri dormivano su dei pagliericci per terra. Dopo tre anni fummo trasferiti nel centro di raccolta profughi nella Villa Reale di Monza.

L’Ingresso del centro profughi di Monza

La scuderia (stalla per cavalli) della Villa Reale

L’attuale edificio che un tempo aveva ospitato i profughi, oggi è un liceo artistico
Quali sono i ricordi più lucidi che ancora conservi?
Diversi, si viveva nell'indigenza e di giochi non se ne avevano, ovviamente. Ricordo però, che utilizzavo le parti di una valigia di cartone, che conservo ancora oggi, come se fossero dei mattoncini dei lego. Nonostante la condizione difficile, i nostri genitori ci insegnarono a vivere con diligenza, ma una volta ruppi una finestra con una fionda e venni rimproverato. Un altro ricordo legato a Carrara è di quando mio padre tornava dal lavoro, prendevo alcune sardine appena pescate, le sciacquavo nel mare mangiandole crude. A metà gennaio, sono tornato nella Villa Reale di Monza. Oggi, nella stalla dove eravamo "ospitati", ci sono le aule degli studenti del liceo artistico. Mi ha fatto un certo effetto vedere molte cose, soprattutto lo scalone di un'ala dell'edificio in cui mia madre mi aveva proibito di andare.

Maria Godetz
Come cambiò la tua vita quando riusciste ad uscire dal centro di profughi di Monza?
Avevo 6 anni, l'anno preciso in cui potevo incominciare la scuola. Mio padre riuscì per la prima volta a guadagnare abbastanza per pagare un affitto. Poi i miei genitori presero in gestione per qualche anno un circolo Acli, in cui davo una mano anche io. Dei primi anni di scuola ricordo l'imbarazzo che si provava a portare un cognome austriaco, ma con il tempo la cosa è passata e, una volta ottenuta una stabilità economica migliore (visto che a pesare era soprattutto la condizione di povertà rispetto agli altro) tutto si è ristabilito. Ho sempre fatto alternanza scuola-lavoro in pratica (Slamitz incontrerà a breve gli alunni dell'Istituto Agnesi di Merate proprio per parlare di questo argomento, ndr). Finite le scuole dell'obbligo, invece, mi chiamarono per lavorare alla Pirelli. Decisi che avrei lavorato senza però poter smettere di studiare, così mi iscrissi alle scuole serali. Da quando mi sono diplomato ho svolto diversi lavori, fu grazie ad un mio compagno di squadra, perché ho sempre giocato a calcio, che entrai nel mondo della radiologia. Nella mia carriera ho visitato tanti paesi del mondo, sono stato tecnico e dirigente per una grande multinazionale, ho perso il lavoro per alcune vicissitudini e, rimboccandomi le mani, mi sono rimesso a fare manutenzioni in giro per il mondo. Alcuni di ragazzi di oggi non li capisco, pretendono di trovare lavoro sotto casa e alle migliori condizioni. Consiglio sempre due cose: di prendersi meno sul serio e “fare sacrifici” , che un lavoro si trova.

Una foto di gruppo dei profughi nel centro di raccolta a Marina di Massa
Trovi delle analogie, infine, tra la tua condizione di profugo, di quando eri appena un bambino, rispetto a quella che vivono i profughi dei nostri giorni?
Decisamente poche. Sono stato volontario della Protezione civile, mi è capitato di accompagnare alcuni rifugiati in una cascina della bergamasca. Per quanto posso raccontare, i rifugiati con cui ho avuto a che fare non hanno fatto altro che lamentarsi per tutto il tempo, non andavano bene le vivande che gli erano state consegnate, volevano poter chiamare i loro famigliari quanto prima, anche se non era ancora possibile. Io non sono contro l'accoglienza, ma questi profughi hanno troppe pretese. Nel nostro caso, ci si accontentava di quello che si aveva, lo Stato dava 100 lire per ogni componente della famiglia, 125 per il capofamiglia. Si viveva con quello, e il più lo si poteva guadagnare lavorando. Allora, le persone non ti giudicavano, non abbiamo mai sofferto per delle discriminazioni.
A.S.