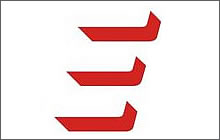10. PAROLE STESE AL SOLE
10. Parole stese al sole
(Alda Merini)

La Piera e l'Enrica si incrociavano sempre alla Messa delle otto e mezza del mattino, che ci andavano tutti i giorni, prima, quando si poteva uscire e non ascoltarla per radio, che adesso il "uirus" come lo chiamavano loro, con la "u" iniziale, le aveva confinate in casa.
I "giuvinòtt" come i loro nipotini gliel'avevano detto: "Noi lavoriamo da casa, con lo "smàrfon", che adesso si può fare tutto con quello. Perché non ne comperi uno anche tu, così ti tieni in contatto col mondo?"
"Tè ce l'hai lo smàrfon?" aveva chiesto dalla finestra l'Enrica alla Piera, quando l'aveva vista alla finestra. Che la curava. Cioè, non è che curasse lei, semplicemente stava alla finestra da tempo, a guardare fuori, la strada, cercare se casomai passasse qualcuno, per avere almeno una distrazione. "Va', g'hè in gir nisun!", diceva tra sé delusa. Che se ci fosse stato qualcuno a passeggiare o a correre ne sarebbe stata contrariata di quella rabbia triste delle persone sole: "Va' lì: ueh tè, giovane, non lo sai mica che bisogna stare in casa? Va' a cà tua, minga sta' in gir a curr!", gli avrebbe detto. Ma almeno avrebbe avuto qualcosa di nuovo a cui pensare.
Invece non c'era in giro nessuno. Per questo, quando aveva visto la Piera non aveva resistito: "Tè ce l'hai lo smàrfon?".
"Eh?", le aveva risposto la Piera dalla finestra. Che non è che non l'avesse sentita o non avesse capito, è che la Piera rispondeva sempre "Eh?" a tutti, la prima volta che le dicevano una cosa.
"Come la va?" diceva l'Enrica.
"Eh, si tira auanti...", con la "u" di "uirus", appunto.
"Cià che vado dentro a metter su il bollito!", aveva chiuso lì l'Enrica, come se avesse una squadra di calcio da sfamare, che la solitudine finge sempre di essere impegnatissima.
E la Piera aveva richiuso le tendine della finestra, che non la vedesse che era ancora lì, con un po' di parole rimaste in sospeso. Niente di che, solo qualche discorso vago, tanto per passare un po' il tempo.
"Enrica!", la chiama. "Enricaaaa!".
Niente. Vuoi vedere che sta mettendo su davvero il bollito? Storna come una campana...: "Enrica, oh?", la ciama di nuovo. Che non ha lì niente sottomano, ma se fosse giù in cortile prenderebbe un paio di sassi da tirarle sulla finestra come quella volta da bambina che l'aveva fatto per chiamare la sua povera mamma Maria, e invece s'era affacciato alla finestra il pa' ‘Mbrusìn, e quando era sceso l'aveva suonata ben bene, che il papà Ambrogio aveva le mani grosse da contadino e non si faceva remore a usarle, perché "le piante si indrizzano quando sono ancora giovani", diceva. E i giovani di quei tempi in effetti non erano mica cresciuti storti.
Perché le venivano in mente adesso questi ricordi della sua giovinezza?
"Enrica, oh?"
"S'è gh'è?", berciò l'Enrica.
"T'a gh'è bisogn una quei garotula per fa' ‘l less?" le chiede. Che aveva conservato qualche carota ancora dal raccolto del suo piccolo orticello, e nel bollito ci vogliono quelle buone, non quelle del supermercato.
"Eh, varda, se me ne dai una la prendo volentieri", le dice.
"Femm inscì: lìghi un sachètt sul filo del bugàa e te lo tiri di lì: va ben?"
"Braua!"
Tra le loro finestre era teso con una carrucola dai tempi della Seconda Guerra un filo consunto che ogni tanto usavano per stendere i canovacci. Ormai era molle e sfilacciato come le frange di una vecchia coperta, ma "l'è mio, l'è tuo, tocca a me, tocca a te", nessuna di loro due si era mai sognata di metterci mano, e così era rimasto lì, utile adesso che alla televisione dicevano che il Paese era ancora in Guerra. E loro la guerra l'avevano vista davvero e avrebbero mandato uolentieri a da' via i ciapp questi qui in cravatta che parlavano di "guerra" adesso. Che loro la fame lo sapevano davvero cos'era, e la paura, e la morte.
"A buon rendere, ‘lora", le dice l'Enrica, mentre riavvolge la carrucola e tira il sacchetto dalla sua parte.
"Cià che vado anch'io a mett sù ‘n quei coss ‘n zul fœuch", strascica la Piera, stropicciandosi come suo solito le mani.
E le finestre si chiudono, e sul filo rimangono lì le parole non dette.
"Ti va se quando è pronto, ti mando di lì un pentolino con un po' di brodo e qualche aletta di gallina?", le avrebbe voluto dire l'Enrica.
"Ma sei sicura che ‘sto filo tiene?", avrebbe riso la Piera, scuotendolo per saggiarne la resistenza.
"Al massimo bòrla giù tutto in strada!", avrebbe riso l'Enrica.
"Tanto non passa nessuno, che per legge non si può!"
"E se passa qualcuno, pem! una bella padellata di brodo caldo in testa e ciàpala! Così t'impari a stare a ca' tua, che il Gouerno te l'ha detto bello chiaro"
"E, ma saria propi un pecàa, tràa via ‘l less con quei bei garotul ‘nscì bunn!"
"E, glielo facciamo ‘sagiare anche a lui, al runner!"
"Uè, Enrica, parli in giargianess?"
Mentre dietro le finestre ognuna di loro cucinava la propria solitudine, le parole non dette si rincorrevano sul filo, avanti e indietro, si mischiavano tra loro come vecchie amiche, abbracciandosi - loro che potevano - e picchiettando sui vetri, ora dell'Enrica ora della Piera.
"T'a me ciamada? Mi hai chiamata?", dice la Piera aprendo la sua, proprio mentre l'Enrica si affaccia anche lei.
E le parole non dette si infilano di corsa nelle loro cucine, si scambiano di posto, annusano il profumo del brodo di pollo, danzano sopra le volute di fumo e riescono fuori, a mischiarsi ai profumi di quella strana primavera.
E io passavo sotto le loro finestre in scarpette da corsa e maglietta giallo fluo, e appoggiato al muro per prendere fiato le sentivo ridere di sopra. Non capivo per filo e per segno ogni loro parola, che il dialetto lo so, ma il dialetto degli anziani è ancor più particolare. Ma le loro parole avevano una musica divertita, non pesante di solitudine. E nel vicolo un odore buonissimo di brodo, e voglia di casa.
POSTILLA
È venerdì 21 giugno 1630, e in una Milano devastata dalla peste piove. Un passante rasente al muro con un foglio in mano, come se scrivesse, striscia le dita sulla parete per pulirle dall'inchiostro. Affacciata alla finestra Caterina Trocazzani, vedova di Alessandro Rosa, vede la scena e sospetta di lui. Un'altra vicina, Ottavia Persici, moglie di Giovanni Bono, le dà manforte e danno l'allarme: l'uomo si chiama Guglielmo Piazza, è un commissario della sanità e durante il suo giro di ispezione stava prendendo nota delle abitazioni già controllate, accostandosi al muro per ripararsi dalla pioggia battente. Scambiato per un untore viene arrestato e, ignaro di tutto, interrogato, coi metodi spicci di allora. viene rasato, purgato e torturato. Sfinito dai tormenti e confidando nell'impunità promessa ai delatori fece il nome della prima persona che gli venne in mente: Gian Giacomo Mora, un barbiere che per arrotondare i guadagni vendeva sottobanco degli unguenti contro la peste preparati da lui. Fu arrestato e, stravolto dalle torture, confessò ciò che non aveva mai fatto: di aver fornito "sostante pestifere" al Piazza per ungere i muri e le porte della città...
Inizia così la "Storia della Colonna Infame", l'opera che nacque contemporaneamente alla stesura del "Fermo e Lucia" nel 1823, come excursus collegato al cap. V del quarto tomo e pubblicata invece solo nel 1842, come appendice all'edizione definitiva dei "Promessi Sposi".
Ho voluto chiudere anch'io, con due donne alla finestra, questo mio breve viaggio in dieci novelle in compagnia dei lettori di Merateonline, Leccoonline e Casateonline: ho cercato in questi racconti di mettere al servizio della fantasia e della pace le mie parole in settimane in cui le parole dei mezzi di comunicazione sembrano uno stillicidio di Male, e la retorica degli slogan si svuota a ogni morto che si aggiunge e a ogni nuovo modello di autocertificazione. "Andrà tutto bene" un fico secco! direbbero le mie due nonnine di sopra, che al posto degli arcobaleni e delle bandiere italiane mettono alla finestra il profumo della loro vita concreta. Lo sanno loro e ve lo dico anch'io che è questa che ci salverà.