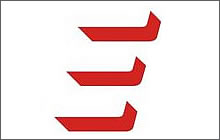''La Bifanìa'': un augurio in poesia

Stefano Motta
''Befana'' è ormai insulto desueto anche se tutto sommato simpatico ed è, come molti termini che usiamo a volte inconsapevolmente, una storpiatura popolare della parola colta, di etimo greco, “epifania”, dal greco ἐπιφαίνω = mostrarsi, presentarsi, perché la festa liturgica dell’Epifania ricorda la “manifestazione” di Gesù che si rivela ai Magi per quello che è. Col passare del tempo, attraverso un processo di storpiatura e corruzione lessicale venne modificata in “bifanìa” (come dice mio figlio di quattro anni), “befanìa”, “befana”.
Tra le liriche solo apparentemente bamboleggianti di Pascoli (se si capisse il senso vero, vertiginoso e heideggeriano della sua “poetica del fanciullino” la si smetterebbe di usarlo come poeta da zucchero filato) c’è questo racconto in versi, tanto facile nel suo ritmo cadenzato e ripetitivo che non c’è adulto di oggi cui non l’abbiano fatto imparare a memoria al tempo delle scuole elementari, quando a scuola ognuno faceva il suo mestiere, e i genitori non sindacavano il lavoro delle maestre, e le maestre avevano il coraggio di dare compiti nobili e di qualità.
Provate a leggerla ad alta voce (perché la poesia è essenzialmente questione di suono, di musica: che stupido “leggere” le poesie sui libri di scuola senza “sentire” come suonano. Un po’ come leggere il testo di “Albachiara” senza la voce strinata di Vasco), sentitene il ritmo: strofette di cinque versi ottonari, costruite “a sandwich” con l’ultimo verso che riprende pressoché testualmente il primo in un distico conclusivo a rima baciata che “chiude” la strofetta pentastica. È uno stratagemma che Ariosto portò alla perfezione con le sue ottave narrative; qui lo troviamo “declassato” per contenuti (non i Paladini di Carlo Magno ma la Befana), per metrica (non l’endecasillabo – il verso per eccellenza della poesia italiana – ma ottonari, più popolari, più folklorici), per durata (strofe pentastiche al posto delle ottave del “Furioso”). Ma l’effetto è lo stesso: tanti piccoli quadretti, efficaci nella loro struttura chiusa a cornice, tanti fermo-immagine di un racconto che procede quasi a singhiozzo, al ritmo del passo pesante e stanco: provate a leggerla mentre passeggiate, come facciamo ogni volta che parliamo al cellulare. Vedrete che adagio adagio il ritmo del nostro passo si adeguerà alla cadenza inesorabile degli ottonari, delle ripetizioni, dei polisindeti.
E il “passo” è uno dei momenti-chiave del raccontino in versi, il passo della mamma che scende adagio le scale per riempire di dolci le calze dei suoi figli, senza farsi accorgere, sorridendo come tutti noi papà abbiamo fatto la notte di Natale, ricordandoci di mordicchiare il biscotto e bere un sorso del latte che i nostri bambini avevano lasciato per Babbo Natale o per Gesù Bambino (a seconda dell’antropologia di ciascuna famiglia). Che poi i nostri figli hanno capito che Babbo Natale si rifornisce da Amazon come il papà, e che Gesù Bambino usa la stessa carta-regalo della mamma, ma il Natale, come la poesia, ha regole e finzioni proprie che nessuna considerazione realistica e prosastica riuscirà a smontare.
Tra le liriche solo apparentemente bamboleggianti di Pascoli (se si capisse il senso vero, vertiginoso e heideggeriano della sua “poetica del fanciullino” la si smetterebbe di usarlo come poeta da zucchero filato) c’è questo racconto in versi, tanto facile nel suo ritmo cadenzato e ripetitivo che non c’è adulto di oggi cui non l’abbiano fatto imparare a memoria al tempo delle scuole elementari, quando a scuola ognuno faceva il suo mestiere, e i genitori non sindacavano il lavoro delle maestre, e le maestre avevano il coraggio di dare compiti nobili e di qualità.
Provate a leggerla ad alta voce (perché la poesia è essenzialmente questione di suono, di musica: che stupido “leggere” le poesie sui libri di scuola senza “sentire” come suonano. Un po’ come leggere il testo di “Albachiara” senza la voce strinata di Vasco), sentitene il ritmo: strofette di cinque versi ottonari, costruite “a sandwich” con l’ultimo verso che riprende pressoché testualmente il primo in un distico conclusivo a rima baciata che “chiude” la strofetta pentastica. È uno stratagemma che Ariosto portò alla perfezione con le sue ottave narrative; qui lo troviamo “declassato” per contenuti (non i Paladini di Carlo Magno ma la Befana), per metrica (non l’endecasillabo – il verso per eccellenza della poesia italiana – ma ottonari, più popolari, più folklorici), per durata (strofe pentastiche al posto delle ottave del “Furioso”). Ma l’effetto è lo stesso: tanti piccoli quadretti, efficaci nella loro struttura chiusa a cornice, tanti fermo-immagine di un racconto che procede quasi a singhiozzo, al ritmo del passo pesante e stanco: provate a leggerla mentre passeggiate, come facciamo ogni volta che parliamo al cellulare. Vedrete che adagio adagio il ritmo del nostro passo si adeguerà alla cadenza inesorabile degli ottonari, delle ripetizioni, dei polisindeti.
E il “passo” è uno dei momenti-chiave del raccontino in versi, il passo della mamma che scende adagio le scale per riempire di dolci le calze dei suoi figli, senza farsi accorgere, sorridendo come tutti noi papà abbiamo fatto la notte di Natale, ricordandoci di mordicchiare il biscotto e bere un sorso del latte che i nostri bambini avevano lasciato per Babbo Natale o per Gesù Bambino (a seconda dell’antropologia di ciascuna famiglia). Che poi i nostri figli hanno capito che Babbo Natale si rifornisce da Amazon come il papà, e che Gesù Bambino usa la stessa carta-regalo della mamma, ma il Natale, come la poesia, ha regole e finzioni proprie che nessuna considerazione realistica e prosastica riuscirà a smontare.
C’è tanto altro da dire su questa poesiola (la simbologia della casa-nido, le due case contrapposte, con la seconda che richiama ancora e sempre “X Agosto” e la mamma singhiozzante della “Cavalla storna”), ma non siamo a scuola. Non ancora, non più (per ora). Intanto buona Befana a tutti!
Viene viene la Befana
vien dai monti a notte fonda.
Come è stanca! La circonda
neve, gelo e tramontana.
Viene viene la Befana.
Ha le mani al petto in croce,
e la neve è il suo mantello
ed il gelo il suo pannello
ed il vento la sua voce.
Ha le mani al petto in croce.
E s’accosta piano piano
alla villa, al casolare,
a guardare, ad ascoltare
or più presso or più lontano.
Piano piano, piano piano.
Che c’è dentro questa villa?
Uno stropiccìo leggero.
Tutto è cheto, tutto è nero.
Un lumino passa e brilla.
Che c’è dentro questa villa?
Guarda e guarda…tre lettini
con tre bimbi a nanna, buoni.
guarda e guarda…ai capitoni
c’è tre calze lunghe e fini.
Oh! tre calze e tre lettini.
Il lumino brilla e scende,
e ne scricchiolan le scale;
il lumino brilla e sale,
e ne palpitan le tende.
Chi mai sale? Chi mai scende?
Co’ suoi doni mamma è scesa,
sale con il suo sorriso.
Il lumino le arde in viso
come lampada di chiesa.
Co’ suoi doni mamma è scesa.
La Befana alla finestra
sente e vede, e s’allontana.
Passa con la tramontana,
passa per la via maestra,
trema ogni uscio, ogni finestra.
E che c’è nel casolare?
Un sospiro lungo e fioco.
Qualche lucciola di fuoco
brilla ancor nel focolare.
Ma che c’è nel casolare?
Guarda e guarda… tre strapunti
con tre bimbi a nanna, buoni.
Tra la cenere e i carboni
c’è tre zoccoli consunti.
Oh! tre scarpe e tre strapunti…
E la mamma veglia e fila
sospirando e singhiozzando,
e rimira a quando a quando
oh! quei tre zoccoli in fila…
Veglia e piange, piange e fila.
La Befana vede e sente;
fugge al monte, ch’è l’aurora.
Quella mamma piange ancora
su quei bimbi senza niente.
La Befana vede e sente.
La Befana sta sul monte.
Ciò che vede è ciò che vide:
c’è chi piange e c’è chi ride;
essa ha nuvoli alla fronte,
mentre sta sull’aspro monte.
vien dai monti a notte fonda.
Come è stanca! La circonda
neve, gelo e tramontana.
Viene viene la Befana.
Ha le mani al petto in croce,
e la neve è il suo mantello
ed il gelo il suo pannello
ed il vento la sua voce.
Ha le mani al petto in croce.
E s’accosta piano piano
alla villa, al casolare,
a guardare, ad ascoltare
or più presso or più lontano.
Piano piano, piano piano.
Che c’è dentro questa villa?
Uno stropiccìo leggero.
Tutto è cheto, tutto è nero.
Un lumino passa e brilla.
Che c’è dentro questa villa?
Guarda e guarda…tre lettini
con tre bimbi a nanna, buoni.
guarda e guarda…ai capitoni
c’è tre calze lunghe e fini.
Oh! tre calze e tre lettini.
Il lumino brilla e scende,
e ne scricchiolan le scale;
il lumino brilla e sale,
e ne palpitan le tende.
Chi mai sale? Chi mai scende?
Co’ suoi doni mamma è scesa,
sale con il suo sorriso.
Il lumino le arde in viso
come lampada di chiesa.
Co’ suoi doni mamma è scesa.
La Befana alla finestra
sente e vede, e s’allontana.
Passa con la tramontana,
passa per la via maestra,
trema ogni uscio, ogni finestra.
E che c’è nel casolare?
Un sospiro lungo e fioco.
Qualche lucciola di fuoco
brilla ancor nel focolare.
Ma che c’è nel casolare?
Guarda e guarda… tre strapunti
con tre bimbi a nanna, buoni.
Tra la cenere e i carboni
c’è tre zoccoli consunti.
Oh! tre scarpe e tre strapunti…
E la mamma veglia e fila
sospirando e singhiozzando,
e rimira a quando a quando
oh! quei tre zoccoli in fila…
Veglia e piange, piange e fila.
La Befana vede e sente;
fugge al monte, ch’è l’aurora.
Quella mamma piange ancora
su quei bimbi senza niente.
La Befana vede e sente.
La Befana sta sul monte.
Ciò che vede è ciò che vide:
c’è chi piange e c’è chi ride;
essa ha nuvoli alla fronte,
mentre sta sull’aspro monte.
(G. Pascoli, La Befana)
Stefano Motta