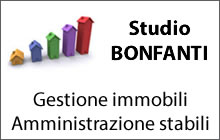Franco Zardoni: ''l’orto è il legame con Cernusco, la mia terra. I miei maestri? Mio padre partigiano, Fortini, padre Turoldo''. Avanguardia operaia, Cub, antifascismo, la renitenza alla leva
Cinquant'anni fa il Sessantotto. Una data convenzionale per rappresentare un movimento socio-culturale che nasce prima e prosegue poi. Manifestazioni, scontri e iniziative che vedono il proprio epicentro nelle città più grandi, ma che si ripercuotono anche in provincia. La protesta studentesca non attecchisce nel Meratese. Le rivendicazioni operaie invece sì, alimentate da giovani che si riconoscono politicamente nei movimenti della sinistra extraparlamentare. Avanguardia operaia, Lotta continua, Servire il popolo e nel lecchese anche il Movimento studentesco. Tutti con i propri distinguo, ma accomunati dalla medesima matrice antifascista. Non certo di maniera, ma di strenuo contrasto all'estrema destra, che in quel periodo sfocia anche nell'eversione con tentativi golpisti sul piano nazionale. Con una serie di interviste cercheremo di conoscere alcuni dei protagonisti della nostra zona che hanno vissuto la stagione del Sessantotto. Ognuno in maniera diversa, compiendo scelte - allora come in seguito - differenti l'uno dall'altro.

IL CORTEO IN PIAZZA PRINETTI A MERATE
La fotografia proviene dall'archivio di Sergio Viganò ed è inserita nella mostra curata dal
circolo Arci La Lo.Co. di Osnago, attualmente allestita nel giardino esterno alla stazione ferroviaria.
Franco Zardoni, classe 1949, oggi risiede a Novate Milanese. Il legame con Cernusco Lombardone dove è cresciuto lo mantiene coltivando l'orto in un terreno di famiglia vicino al torrente Molgora. "È il simbolo dell'unità famigliare voluta dal nonno, che ha lasciato in eredità ai tre figli la terra".
È lì che fissiamo l'incontro e, inevitabilmente, si comincia a parlare di questa ultima passione, sopraggiunta non più di una decina di anni fa a partire da un grattacapo notturno. Con un personaggio come lui, passare nella discussione dalla rotazione delle colture nei campi all'azione politica è tutt'altro che impensabile.
«Ho calcolato che 100 metri quadrati di terreno coltivato a orto producono 10 mila euro all'anno di alimenti. A Novate Milanese negli anni passati mi sono messo in moto per creare una cooperativa che desse un'opportunità di reddito ai giovani, a investimento zero. C'era un gruppo di ragazzi interessati, ma alla fine l'idea non è mai andata in porto. Al primo articolo dello statuto della cooperativa si diceva: "se avete 100 metri quadrati di vostro padre o vostro nonno che sono inutilizzati, traduceteli in campi da coltivare". Sono affascinato dai principî dell'economia della condivisione. Poi servirebbe naturalmente un progetto di fattibilità serio. Senza quello non si va da nessuna parte. Ho da sempre pensato che bisogna coltivare l'idea del pensiero laterale, alcuni lo chiamano pensiero debole. È la capacità di inventarsi un paradigma nuovo, che nello stato attuale serve».

IL CORTEO IN PIAZZA PRINETTI A MERATE
La fotografia proviene dall'archivio di Sergio Viganò ed è inserita nella mostra curata dal
circolo Arci La Lo.Co. di Osnago, attualmente allestita nel giardino esterno alla stazione ferroviaria.
Nella sua vita, oggi come in passato, ha mai avuto però dei punti di riferimento, dei maestri di vita?
«Certamente. Senz'altro mio padre. È stato un partigiano. Mi ha insegnato i valori dell'impegno sociale, dell'onestà. Poi Franco Fortini Lattes, era un intellettuale ermetico, ha scritto per il Politecnico. Ha tradotto Goethe e i lavori di Brecht. Già nel '66 vestiva in modo diverso, era un personaggio stranissimo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando studiavo a ragioneria al Mosè Bianchi di Monza. Era il suo primo o secondo anno di insegnamento. Si rifiutò di giurare al fascismo e per questo non gli era stata assegnata prima una cattedra. Con lui ho imparato la dottrina, anche se già ero invaso di letture. Compravo i libri con i soldi che mia madre mi dava per la mensa. Un'altra figura per me importante è stato Padre David Turoldo, pur non essendo credente. Con lui ho passato molti sabati e domeniche. Con piacere ricordo la visita a Nomadelfia, la città dei ragazzi. Lì, al posto dell'orfanotrofio, con volontari maschi e femmine, veniva riprodotto il nucleo famigliare. Da Nomadelfia sono usciti poi molti ragazzi che hanno ottenuto grandi successi».
Qual era il suo rapporto con la religione?
«Sono sempre stato interessato alla filosofia e alla teologia. Pensavo di laurearmi in filosofia. Avevo frequentato qualche corso all'università. Volevo risolvere la mia inquietudine sulla morte. Non ci sono riuscito, oggi forse è anche peggio. All'epoca cercavo di confrontarmi con l'area cattolica di sinistra, guardavo con interesse alla teologia della liberazione in Sud America. Anche nel Meratese nascevano delle realtà spontanee, esponenti qualificati del cattolicesimo. Si faceva parecchia ricerca sociale, si affrontava la teologia pastorale. Ho letto tutti i libri del Cardinal Carlo Maria Martini. Una volta venne in Pirelli, era la fine degli anni Settanta, già alla fine della spinta rivoluzionaria. Parlò di umanesimo cristiano da cardinale, da teologo aperto».
Qual è stata la sua esperienza in Pirelli?
«È stato il mio primo e unico lavoro. Sono entrato come informatico nell'aprile del '69. Nell'aprile del '70 mi sono fermato fino al '72, quando sono ritornato e alla prima assemblea sono subito intervenuto. In Pirelli ho preso parte al CUB, un'esperienza innovativa che comincia proprio lì»
All'epoca però lei stava in Avanguardia Operaia...
«Era come entrare in un'altra porta, ma dello stesso appartamento. Il CUB era autonomo, ma in un certo senso era riferibile ad Avanguardia Operaria. Era come un plus rispetto all'adesione ad Avanguardia Operaia. Il Comitato Unitario di Base era aperto, in Avanguardia Operaia erano più selettivi».
Quali incarichi ha avuto in Avanguardia Operaia?
«Ero il referente del Lecchese e del Comasco. Sono stato membro della segreteria regionale e del direttivo nazionale. Successivamente avrei avuto l'opportunità di candidarmi nel sindacato o nei partiti, ma ho sempre preferito stare in mezzo alla gente, tra gli ultimi».
Ha parlato di un periodo dal '70 al '72 in cui non ha lavorato. È stato a causa della sua obiezione di coscienza, illegale secondo la legge?
«Ho voluto dichiarare pubblicamente di essere obiettore di coscienza perché era un gesto politico, una critica a un modello sociale, culturale e politico. Il tribunale di La Spezia aveva emesso un mandato di cattura e mi avrebbero mandato a Spotorno, dove c'era la scuola di Sottufficiali della Marina militare. Il mio avvocato è riuscito a togliere il mandato di cattura. Io non avevo mai fatto domanda di andare lì e in Marina si può andare solo su richiesta spontanea. Così sono stato giudicato del tribunale di Torino e ho dovuto scontare 3 mesi al carcere di Peschiera sui 5 mesi e 20 giorni a cui ero stato condannato».
Qual è stato il suo ruolo a Cernusco Lombardone e nel territorio?
«A Cernusco abbiamo dato vita a un Comitato di intervento. Volevamo fare qualcosa di concreto. Abbiamo organizzato un doposcuola per ragazzi. Era una risposta per essere presenti con un aiuto pratico alle famiglie che erano in difficoltà. È inutile parlare di poveri e poi non fare niente. Mi sarebbe piaciuto che i circoli del PD assumessero una configurazione similare, di presenza concreta nel sociale».
Qual è stato l'impegno antifascista che avete sostenuto?
«Ricordo a Merate una grande manifestazione. C'era la piazza piena di persone che avevano aderito alla mobilitazione. Il centro era stato militarizzato. Un numero impressionante di forze dell'ordine. Era arrivata la seconda celere di Padova. Quella volta ci furono diversi arresti. Un'altra contromanifestazione è stata a Giulino di Mezzegra, il 28 aprile, dove i fascisti avevano organizzato una commemorazione a Mussolini e la Petacci. A Lecco siamo saliti su un battello da 200-300 persone verso Giovino di Mezzegra e lì abbiamo sfilato in corteo».
Ci sono stati scontri?
«I fascisti non si sono presentati quella volta. In ogni corteo era comunque attivo il servizio d'ordine, come elemento di autodifesa e prevenzione. A Milano era molto più facile che si verificassero atti violenti».
Qual era il rapporto con il servizio d'ordine?
«C'è stata una fase in cui il servizio d'ordine avrebbe voluto maggiore autonomia. In Segreteria regionale e nel Direttivo nazionale si è affrontata la questione. Personalmente, sull'argomento mi sono schierato affinché il responsabile del servizio d'ordine rispondesse al responsabile politico. Io mi sono sempre opposto, all'uso della violenza e non è mai stata autorizzata da parte mia. Non perché sono pacifista. È un sentimento di fondo. Io mi do un orizzonte. Come ci arrivo? Cerco di rimuovere gli attriti. Ho sempre creduto nell'opera di convincimento e nella capacità oratoria. Da questo punto di vista, ne sono un esempio Pajetta, Lombardi e devo riconoscere l'arte retorica anche di Almirante. Personalmente prima di un confronto mi documento, devo essere informato. Non c'è democrazia senza conoscenza, informazione e studio».
Articoli correlati
Marco Pessina