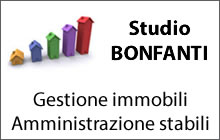"Agnesi e Viganò" e la Resistenza delle donne
Nella mattinata di mercoledì 26 marzo, gli istituti Viganò e Agnesi hanno presentato il progetto "La memoria intorno a noi: luoghi, parole e voci a 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo".

Ad accogliere i presenti nell’aula Borsellino la professoressa Stefania Brigatti, la dirigente dell'Agnesi Sabrina Scola e la dirigente del Viganò Carmen Saffioti. “A distanza di 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è importante parlare di Resistenza per la difesa di diritti per i quali in tanti hanno lottato in quegli anni”. Presenti in rappresentanza del Comune l'assessora Patrizia Riva e il consigliere Michele Magrin. “Parlare delle donne nella Resistenza non è scontato, difatti le donne sono sempre state sottaciute e sono passate nel silenzio, nonostante abbiano fatto tantissimo”.

Da casa le donne hanno deciso di fare le “resistenti” con le azioni quotidiane, portando avanti la famiglia e l'economia, organizzando le staffette e diventando le figure di collegamento tra i partigiani, imbracciando il fucile quando necessario. “Le donne hanno subito in prima persona tutte le brutture della guerra. Di questo si è sempre parlato poco e male, farlo oggi significa riportare alla luce il loro lavoro, il loro pensiero e modo di essere che fino ad oggi non è stato tanto tracciato” ha concluso l'assessora, augurando agli alunni di preservare i diritti che per legge sono uguali per tutti.

A prendere la parola sono stati dunque la dottoressa Elisabetta Ruffini, ricercatrice dell'istituto storico della Resistenza di Bergamo e il professore Alberto Magni di ANPI, che hanno raccontato la guerra seguendo la categoria dell'amicizia, come ha insegnato il ricercatore Angelo Bendotti. “Le amicizie tra i partigiani sono durate ben dopo la guerra perché erano costruite in montagna durante i combattimenti, partendo da legami franchi tra uomini e donne che sono a fondamento del nostro paese”. La dottoressa ha avviato una riflessione sul ruolo della donna nella Resistenza, una prospettiva che solamente negli ultimi anni si sta realmente prendendo in considerazione per portare avanti la memoria della nazione, ricordando alcune figure significative.

Nel 1949 Maria Maddalena Rossi, una chimica, comunista e presidente di “Unione donne italiane” prende la parola in parlamento per promuovere una campagna della pace lanciata dalle ex partigiane. La raccolta porterà le italiane a consegnare 3 milioni di firme all'ONU per fermare la corsa agli armamenti e la ricerca sulla bomba atomica. Rossi lavorava al giornale clandestino “L'Unità” dove incontrò la giornalista Velia Sacchi, che insieme a Mimma Quarti fondarono a Bergamo “L'associazione femminile per la pace e la libertà” che confluirà nei gruppi di “Difesa delle donne”.

I più forti scioperi per i diritti furono fatti proprio dalle donne, come quello del 1931 che raccolse 180.000 persone nel novarese per sottolineare come senza pace non possa esistere la libertà. L'8 settembre 1943 fondamentale fu il gesto delle sorelle Angelica e Paola Villa, di Bianca Ceva e Arianna Locatelli e di tutte le donne che di fronte al disfacimento dell'esercito italiano aprirono le loro case per salvare i disertori, ribaltando l'idea che il fascismo aveva messo al centro, ovvero, di donne sostenitrici degli uomini in guerra.

Le donne invece sostenevano coloro che volevano la fine della guerra, i partigiani, impegnandosi oltretutto al ripristino della quotidianità anche quando i compagni venivano condannati, come successe a Giulia Banfi, che trovatasi sola a seguito della deportazione del marito fece di tutto per garantire un futuro dignitoso al figlio. “Queste donne hanno dato la possibilità a noi tutte di parlare oggi e di dire quello che abbiamo pensato con le nostre teste”. Fondamentale è dunque fare memoria per ricordare la pratica quotidiana dell'altruismo, l'antidoto inesauribile contro qualsiasi forma di prepotenza e intolleranza.

Ad accogliere i presenti nell’aula Borsellino la professoressa Stefania Brigatti, la dirigente dell'Agnesi Sabrina Scola e la dirigente del Viganò Carmen Saffioti. “A distanza di 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è importante parlare di Resistenza per la difesa di diritti per i quali in tanti hanno lottato in quegli anni”. Presenti in rappresentanza del Comune l'assessora Patrizia Riva e il consigliere Michele Magrin. “Parlare delle donne nella Resistenza non è scontato, difatti le donne sono sempre state sottaciute e sono passate nel silenzio, nonostante abbiano fatto tantissimo”.

Alberto Magni ed Elisabetta Ruffini
Da casa le donne hanno deciso di fare le “resistenti” con le azioni quotidiane, portando avanti la famiglia e l'economia, organizzando le staffette e diventando le figure di collegamento tra i partigiani, imbracciando il fucile quando necessario. “Le donne hanno subito in prima persona tutte le brutture della guerra. Di questo si è sempre parlato poco e male, farlo oggi significa riportare alla luce il loro lavoro, il loro pensiero e modo di essere che fino ad oggi non è stato tanto tracciato” ha concluso l'assessora, augurando agli alunni di preservare i diritti che per legge sono uguali per tutti.

Le dirigenti Carmen Saffioti e Sabrina Scola
A prendere la parola sono stati dunque la dottoressa Elisabetta Ruffini, ricercatrice dell'istituto storico della Resistenza di Bergamo e il professore Alberto Magni di ANPI, che hanno raccontato la guerra seguendo la categoria dell'amicizia, come ha insegnato il ricercatore Angelo Bendotti. “Le amicizie tra i partigiani sono durate ben dopo la guerra perché erano costruite in montagna durante i combattimenti, partendo da legami franchi tra uomini e donne che sono a fondamento del nostro paese”. La dottoressa ha avviato una riflessione sul ruolo della donna nella Resistenza, una prospettiva che solamente negli ultimi anni si sta realmente prendendo in considerazione per portare avanti la memoria della nazione, ricordando alcune figure significative.

Nel 1949 Maria Maddalena Rossi, una chimica, comunista e presidente di “Unione donne italiane” prende la parola in parlamento per promuovere una campagna della pace lanciata dalle ex partigiane. La raccolta porterà le italiane a consegnare 3 milioni di firme all'ONU per fermare la corsa agli armamenti e la ricerca sulla bomba atomica. Rossi lavorava al giornale clandestino “L'Unità” dove incontrò la giornalista Velia Sacchi, che insieme a Mimma Quarti fondarono a Bergamo “L'associazione femminile per la pace e la libertà” che confluirà nei gruppi di “Difesa delle donne”.

L'assessora Patrizia Riva
I più forti scioperi per i diritti furono fatti proprio dalle donne, come quello del 1931 che raccolse 180.000 persone nel novarese per sottolineare come senza pace non possa esistere la libertà. L'8 settembre 1943 fondamentale fu il gesto delle sorelle Angelica e Paola Villa, di Bianca Ceva e Arianna Locatelli e di tutte le donne che di fronte al disfacimento dell'esercito italiano aprirono le loro case per salvare i disertori, ribaltando l'idea che il fascismo aveva messo al centro, ovvero, di donne sostenitrici degli uomini in guerra.

Le donne invece sostenevano coloro che volevano la fine della guerra, i partigiani, impegnandosi oltretutto al ripristino della quotidianità anche quando i compagni venivano condannati, come successe a Giulia Banfi, che trovatasi sola a seguito della deportazione del marito fece di tutto per garantire un futuro dignitoso al figlio. “Queste donne hanno dato la possibilità a noi tutte di parlare oggi e di dire quello che abbiamo pensato con le nostre teste”. Fondamentale è dunque fare memoria per ricordare la pratica quotidiana dell'altruismo, l'antidoto inesauribile contro qualsiasi forma di prepotenza e intolleranza.
I.Bi.