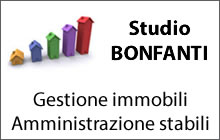Church pocket/48. Criticare il Papa, amare la Chiesa
C'è chi pensa, anche tra le fila dei conventi, che parlare di diritto canonico in una rubrica di teologia e nella chiesa sia un ossimoro. Altri, più critici, leggono in queste righe un pretesto per screditare il Papa o per perpetuare una visione rigida e tradizionale della Chiesa. A chi nutre questi dubbi, voglio rispondere fin da subito: la teologia non è un recinto stretto, è un campo aperto dove il diritto, la storia, la filosofia e la vita reale si possono e si devono incontrare. Il Diritto Canonico non è un semplice elenco di norme; è lo strumento che aiuta la Chiesa a camminare nella storia senza perdere la bussola del Vangelo e soprattutto, studiarlo ci dà la capacità di capire il codice genetico della Chiesa. Non è una critica per il gusto di farla, ma per amore della verità, come ricorda Isaia: “Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace” (Is 62,1) perché l'amore autentico spinge a parlare e a cercare il bene, anche quando farlo può risultare scomodo. Se il Presidente del Consiglio Meloni, disattendesse alle regole da lei stessa create molti griderebbero allo scandalo; non vedo perché io non possa farlo con Bergoglio. Personalmente, posso non condividere alcune scelte pastorali o orientamenti, ma resto fedele e figlio della Chiesa Cattolica. Torniamo al diritto. Ora, immaginiamo una comunità senza regole: un posto dove ognuno fa quello che vuole, senza limiti. Caos? Corretto. È qui che entra in gioco il diritto, quell’insieme di norme che permette a una società di funzionare. Non serve solo a evitare il disordine: il diritto crea le basi per una convivenza pacifica e giusta. Il diritto serve, in estrema sintesi, a garantire tre cose fondamentali: ordine, giustizia e Bene Comune.

Non è un caso che pensatori come Hans Kelsen e Norberto Bobbio abbiano visto il diritto come la spina dorsale di ogni società. Come Kelsen ha notato nella sua famosa “Teoria pura del diritto”, i cui contenuti vengono ancora letti nei corsi di giurisprudenza nelle università, la legge sostiene la struttura della società per la coesistenza pacifica ed è la base di stabilità per qualsiasi gruppo sociale, in quanto genera un solido quadro di regole che devono essere rispettate da tutti. D’altra parte, Bobbio, nella sua opera “Teoria generale del diritto”, afferma che le leggi non sono solo norme, ma sono strumento per gestire conflitti e dialoghi. Secondo Bobbio, il diritto è dinamico: non abolisce i conflitti, ma li organizza e li trasforma in opportunità di crescita civile attraverso il confronto.
E la Chiesa? Anche se non è uno Stato – da non confondersi con la Città del Vaticano o con la Santa Sede – o un’istituzione qualsiasi, la Chiesa Cattolica è una comunità di persone, con relazioni, ruoli e responsabilità. Vive nella storia, tra uomini e donne concreti. E come ogni società, ha bisogno di un sistema di regole: il Diritto Canonico. Questa esigenza di ordine e giustizia non nasce dal nulla, ma la troviamo già nella tradizione biblica. Nell'Antico Testamento, in particolare, la gestione delle controversie nel nascente popolo ebraico post-liberazione era affidata a figure con autorità legale e religiosa, come emerge chiaramente in Deuteronomio 17,8-13. Qui si delinea un modello in cui i giudici non avevano solo il compito di amministrare la giustizia, ma anche di interpretare e custodire la legge, anticipando in un certo senso il ruolo che oggi svolgono i vescovi e i tribunali ecclesiastici. La continuità tra questa antica tradizione e il diritto canonico moderno mostra come la Chiesa abbia sempre sentito il bisogno di strutturarsi attorno a regole che non soffocano la fede, ma la proteggono e la rendono concreta nella vita della comunità. La tradizione normativa vera e propria della Chiesa è costitutiva della stessa comunità: i concili producevano dei canoni, delle regole che erano verità da credersi. Graziano, monaco e giurista del XII secolo, mette ordine in tutte queste fonti giuridiche sciolte con la redazione del Decretum, conosciuto anche come il Corpus Iuris Canonici, in vigore fino alla codificazione del Codice di Diritto Canonico del 1917, chiamato Codice Pio-Benedettino, prima codificazione sistematica del diritto della Chiesa. Oggi la Chiesa cattolica ha due principali codici di diritto canonico, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali cattoliche, entrambi promulgati da Giovanni Paolo II: il Codice di Diritto Canonico (CIC) del 1983 per la Chiesa latina e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) del 1990 per le 23 Chiese cattoliche orientali sui iuris, in comunione con il Papa, ma con riti e discipline diverse da quelle della Chiesa latina. Non si tratta di burocrazia. In fondo, le regole non sono un peso. Sono il telaio su cui si intrecciano i fili della vita ecclesiale.
Come tutte le società post-liberali, anche la Chiesa Cattolica ha una Costituzione. Quando parliamo di Costituzione della Chiesa, non ci riferiamo solo a un testo scritto. La Chiesa ha una doppia dimensione: una Costituzione Formale e una Costituzione Sostanziale, in continua e necessaria osmosi tra loro. La Costituzione Formale è, ovviamente, l’insieme delle norme scritte che regolano l'organizzazione della Chiesa e il funzionamento delle sue autorità. Il Codice di Diritto Canonico, le Costituzioni apostoliche come Praedicate Evangelium fanno parte di questo corpo costituzionale. Questi testi definiscono, tra le tante cose, i ruoli del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti e dei laici; l’organizzazione di diocesi, parrocchie, ordini religiosi, le regole per i sacramenti e la disciplina interna. Sono come le istruzioni di un grande organismo complesso. Il testo Costituzionale Sostanziale della Chiesa è il suo cuore pulsante. Non parliamo di leggi scritte, ma della sua natura teologica e spirituale. La Chiesa è una comunità voluta da Cristo e rivitalizzata dal soffio dello Spirito Santo. La sua vera costituzione, è radicata nella Rivelazione divina, contenuta nella Scrittura, nella Tradizione e nel Magistero, fondata sul principio di collegialità e comunione. Javier Hervada, canonista spagnolo, ci aiuta a distinguere tra “diritto costitutivo” ovvero la sostanza della Chiesa e diritto disciplinare cioè le regole che possono e devono cambiare perché la società è sempre in divenire. La struttura giuridica della Chiesa viene da Cristo, ma le modalità in cui si concretizza dipendono da decisioni umane.
Le due costituzioni non si contrappongono, anzi: la Costituzione Formale e Costituzione Sostanziale sono tra loro in mutuo servizio. Le leggi della Chiesa non creano la sua identità, ma la custodiscono e la rendono visibile. Le regole possono cambiare, come dimostrano le riforme del Diritto Canonico, ma non possono mai contraddire la sostanza della Chiesa, radicata nel Vangelo. Facciamo un esempio pratico: il Primato Petrino. Nella Costituzione Sostanziale, il primato del Papa come successore di Pietro è un dato fondamentale, fondato sul Vangelo “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18-19). Nella Costituzione Formale si disciplinano le modalità di elezione del Papa, come il conclave, o l'organizzazione della Curia Romana. Questi aspetti sono regolati da leggi canoniche che possono essere aggiornate, come ha fatto Papa Francesco con Praedicate Evangelium.

Anche Giovanni Paolo II, con la riforma del Codice di Diritto Canonico e la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, ha ricordato che il diritto canonico non è una semplice burocrazia: è l'espressione concreta della natura stessa della Chiesa. Questo testo è un documento che segna un momento storico per la Chiesa cattolica. Che il Diritto Canonico sia, seppur una materia distinta, legato alla teologia lo dice chiaramente in questo passaggio: “Il nuovo Codice di Diritto Canonico viene promulgato oggi, nel pieno della tradizione ecclesiale. Esso rappresenta non solo una riforma delle leggi precedenti, ma una traduzione in norme giuridiche della dottrina ecclesiologica del Concilio Vaticano II”
(Sacrae Disciplinae Leges, Introduzione). E ancora: “Il Codice, in definitiva, non è altro che uno strumento, benché necessario, per la vita della Chiesa, ordinata secondo la struttura voluta dal suo Fondatore” (Sacrae Disciplinae Leges, § 15).
Capire la Chiesa significa riconoscerla come una realtà viva, con un'anima divina e un corpo fatto di persone, relazioni, regole. La sua Costituzione Sostanziale viene da Dio; la Costituzione Formale è l'abito che cambia con i tempi, senza mai tradire l'essenza. Proprio come un vestito che si adatta alle stagioni e alle esigenze del momento, ma che non può mai snaturare chi lo indossa. Non è solo una questione di leggi. È una questione di identità. Le regole possono sembrare fredde e rigide, ma dietro ogni norma c’è una storia, una comunità che cerca di camminare insieme. La Chiesa non vive di codici, vive di persone che quei codici li scrivono, li interpretano, li mettono in pratica, a volte sbagliando, spesso cercando di fare del proprio meglio. Il diritto canonico, insomma, non è la gabbia della Chiesa, ma il suo scheletro: senza di esso, tutto crollerebbe. La Chiesa non è un museo di regole antiche, ma un laboratorio di fede viva. E il diritto canonico? Il suo manuale d’uso. Ma la vera sfida non è imparare il manuale a memoria. È saperci costruire sopra qualcosa di grande, di vero, di eterno.
Segui Church pocket - Teologia Tascabile su Instagram e Facebook per non perderti le notizie sulla Chiesa in tempo reale.

Non è un caso che pensatori come Hans Kelsen e Norberto Bobbio abbiano visto il diritto come la spina dorsale di ogni società. Come Kelsen ha notato nella sua famosa “Teoria pura del diritto”, i cui contenuti vengono ancora letti nei corsi di giurisprudenza nelle università, la legge sostiene la struttura della società per la coesistenza pacifica ed è la base di stabilità per qualsiasi gruppo sociale, in quanto genera un solido quadro di regole che devono essere rispettate da tutti. D’altra parte, Bobbio, nella sua opera “Teoria generale del diritto”, afferma che le leggi non sono solo norme, ma sono strumento per gestire conflitti e dialoghi. Secondo Bobbio, il diritto è dinamico: non abolisce i conflitti, ma li organizza e li trasforma in opportunità di crescita civile attraverso il confronto.
E la Chiesa? Anche se non è uno Stato – da non confondersi con la Città del Vaticano o con la Santa Sede – o un’istituzione qualsiasi, la Chiesa Cattolica è una comunità di persone, con relazioni, ruoli e responsabilità. Vive nella storia, tra uomini e donne concreti. E come ogni società, ha bisogno di un sistema di regole: il Diritto Canonico. Questa esigenza di ordine e giustizia non nasce dal nulla, ma la troviamo già nella tradizione biblica. Nell'Antico Testamento, in particolare, la gestione delle controversie nel nascente popolo ebraico post-liberazione era affidata a figure con autorità legale e religiosa, come emerge chiaramente in Deuteronomio 17,8-13. Qui si delinea un modello in cui i giudici non avevano solo il compito di amministrare la giustizia, ma anche di interpretare e custodire la legge, anticipando in un certo senso il ruolo che oggi svolgono i vescovi e i tribunali ecclesiastici. La continuità tra questa antica tradizione e il diritto canonico moderno mostra come la Chiesa abbia sempre sentito il bisogno di strutturarsi attorno a regole che non soffocano la fede, ma la proteggono e la rendono concreta nella vita della comunità. La tradizione normativa vera e propria della Chiesa è costitutiva della stessa comunità: i concili producevano dei canoni, delle regole che erano verità da credersi. Graziano, monaco e giurista del XII secolo, mette ordine in tutte queste fonti giuridiche sciolte con la redazione del Decretum, conosciuto anche come il Corpus Iuris Canonici, in vigore fino alla codificazione del Codice di Diritto Canonico del 1917, chiamato Codice Pio-Benedettino, prima codificazione sistematica del diritto della Chiesa. Oggi la Chiesa cattolica ha due principali codici di diritto canonico, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali cattoliche, entrambi promulgati da Giovanni Paolo II: il Codice di Diritto Canonico (CIC) del 1983 per la Chiesa latina e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) del 1990 per le 23 Chiese cattoliche orientali sui iuris, in comunione con il Papa, ma con riti e discipline diverse da quelle della Chiesa latina. Non si tratta di burocrazia. In fondo, le regole non sono un peso. Sono il telaio su cui si intrecciano i fili della vita ecclesiale.
Come tutte le società post-liberali, anche la Chiesa Cattolica ha una Costituzione. Quando parliamo di Costituzione della Chiesa, non ci riferiamo solo a un testo scritto. La Chiesa ha una doppia dimensione: una Costituzione Formale e una Costituzione Sostanziale, in continua e necessaria osmosi tra loro. La Costituzione Formale è, ovviamente, l’insieme delle norme scritte che regolano l'organizzazione della Chiesa e il funzionamento delle sue autorità. Il Codice di Diritto Canonico, le Costituzioni apostoliche come Praedicate Evangelium fanno parte di questo corpo costituzionale. Questi testi definiscono, tra le tante cose, i ruoli del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti e dei laici; l’organizzazione di diocesi, parrocchie, ordini religiosi, le regole per i sacramenti e la disciplina interna. Sono come le istruzioni di un grande organismo complesso. Il testo Costituzionale Sostanziale della Chiesa è il suo cuore pulsante. Non parliamo di leggi scritte, ma della sua natura teologica e spirituale. La Chiesa è una comunità voluta da Cristo e rivitalizzata dal soffio dello Spirito Santo. La sua vera costituzione, è radicata nella Rivelazione divina, contenuta nella Scrittura, nella Tradizione e nel Magistero, fondata sul principio di collegialità e comunione. Javier Hervada, canonista spagnolo, ci aiuta a distinguere tra “diritto costitutivo” ovvero la sostanza della Chiesa e diritto disciplinare cioè le regole che possono e devono cambiare perché la società è sempre in divenire. La struttura giuridica della Chiesa viene da Cristo, ma le modalità in cui si concretizza dipendono da decisioni umane.
Le due costituzioni non si contrappongono, anzi: la Costituzione Formale e Costituzione Sostanziale sono tra loro in mutuo servizio. Le leggi della Chiesa non creano la sua identità, ma la custodiscono e la rendono visibile. Le regole possono cambiare, come dimostrano le riforme del Diritto Canonico, ma non possono mai contraddire la sostanza della Chiesa, radicata nel Vangelo. Facciamo un esempio pratico: il Primato Petrino. Nella Costituzione Sostanziale, il primato del Papa come successore di Pietro è un dato fondamentale, fondato sul Vangelo “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18-19). Nella Costituzione Formale si disciplinano le modalità di elezione del Papa, come il conclave, o l'organizzazione della Curia Romana. Questi aspetti sono regolati da leggi canoniche che possono essere aggiornate, come ha fatto Papa Francesco con Praedicate Evangelium.

Anche Giovanni Paolo II, con la riforma del Codice di Diritto Canonico e la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, ha ricordato che il diritto canonico non è una semplice burocrazia: è l'espressione concreta della natura stessa della Chiesa. Questo testo è un documento che segna un momento storico per la Chiesa cattolica. Che il Diritto Canonico sia, seppur una materia distinta, legato alla teologia lo dice chiaramente in questo passaggio: “Il nuovo Codice di Diritto Canonico viene promulgato oggi, nel pieno della tradizione ecclesiale. Esso rappresenta non solo una riforma delle leggi precedenti, ma una traduzione in norme giuridiche della dottrina ecclesiologica del Concilio Vaticano II”
(Sacrae Disciplinae Leges, Introduzione). E ancora: “Il Codice, in definitiva, non è altro che uno strumento, benché necessario, per la vita della Chiesa, ordinata secondo la struttura voluta dal suo Fondatore” (Sacrae Disciplinae Leges, § 15).
Capire la Chiesa significa riconoscerla come una realtà viva, con un'anima divina e un corpo fatto di persone, relazioni, regole. La sua Costituzione Sostanziale viene da Dio; la Costituzione Formale è l'abito che cambia con i tempi, senza mai tradire l'essenza. Proprio come un vestito che si adatta alle stagioni e alle esigenze del momento, ma che non può mai snaturare chi lo indossa. Non è solo una questione di leggi. È una questione di identità. Le regole possono sembrare fredde e rigide, ma dietro ogni norma c’è una storia, una comunità che cerca di camminare insieme. La Chiesa non vive di codici, vive di persone che quei codici li scrivono, li interpretano, li mettono in pratica, a volte sbagliando, spesso cercando di fare del proprio meglio. Il diritto canonico, insomma, non è la gabbia della Chiesa, ma il suo scheletro: senza di esso, tutto crollerebbe. La Chiesa non è un museo di regole antiche, ma un laboratorio di fede viva. E il diritto canonico? Il suo manuale d’uso. Ma la vera sfida non è imparare il manuale a memoria. È saperci costruire sopra qualcosa di grande, di vero, di eterno.
Segui Church pocket - Teologia Tascabile su Instagram e Facebook per non perderti le notizie sulla Chiesa in tempo reale.
Rubrica a cura di Pietro Santoro