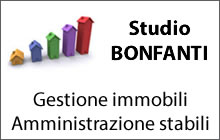Osnago: fascismo, foibe e persecuzione degli slavi. Un incontro partecipato
Il 10 febbraio 1947 l'Italia firmò a Parigi il trattato di pace che pose fine alla guerra con la Jugoslavia, con l’accordo sui nuovi confini e le disposizioni, soprattutto nell'Istria e nella valle dell'Isonzo, che portarono all'esodo giuliano dalmata, ovvero l'emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana o di cittadini italiani di nazionalità mista con sloveni e croati, dalla Venezia Giulia, dal Quarnaro e dalla Dalmazia da un regime totalitario.

Una data riconosciuta dalla Repubblica con la Legge del 30 marzo 2004 come “Giorno del Ricordo”: “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.
Nella serata di martedì 4 febbraio Progetto Osnago e il Comune hanno avviato un percorso diviso in due incontri per approfondire il momento più cruento e disumano dei decenni di contrasti sul confine orientale. La saggista Alessandra Kersevan, con l'aiuto del collaboratore ISREC Gabriele Fontana, ha iniziato il discorso facendo una panoramica dei maggiori eventi che tra la prima e seconda Guerra Mondiale, hanno portato alla rottura dei rapporti di pace con i popoli confinanti ad est. Prima della Prima Guerra Mondiale i territori intorno al Friuli Venezia Giulia facevano parte dell'impero Austro Ungarico, una zona multietnica e multi linguista in stretto rapporto con il popolo italiano su un confine anch'esso molto variegato, una comunanza distrutta con l'avvento dell'ideologia nazionalista.

Durante il primo conflitto mondiale erano già iniziate le prime deportazioni e i primi campi profughi per italiani di origine austro-ungarica che erano sospettati di schierarsi con i nemici, così come quando gli italiani invasero i territori jugoslavi, ampliando di molto il confine del regno ad est, imprigionarono individui che potevano rappresentare una minaccia. 500.000 mila persone di nazionalità norrena e croata furono inglobati dall'Italia, che avviò una campagna di “italianizzazione”, senza rispetto per la cultura e la libertà di questi popoli che venivano considerati poco affidabili. Con l'avvento del fascismo questi territori furono martoriati per il forte sentimento razzista verso gli slavi, furono colpite figure e luoghi simbolici, come il Narodni Dom, la casa della cultura slovena a Trieste, distrutta il 13 luglio 1920, ci furono repressioni poliziesche e giudiziarie, con condanne a morte degli oppositori del regime.

Iniziò un processo di italianizzazione dei toponimi e dei cognomi, venne inoltre bandito da tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento nelle lingue slave e vennero sciolte tutte le organizzazioni economiche, le associazioni culturali e professionali slovene. Violenta fu la reazione delle organizzazioni indipendentiste e terroriste slovene, tra cui il TIGR, acronimo di Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, per il risorgimento dei loro popoli e la fine dell'oppressione italiana. La repressione italiana verso questi popoli si acuì sempre di più, fino a sfociare nell'occupazione della Jugoslavia il 6 aprile 1941, sostenuta dalla Germania che bombardò Belgrado.
L'espansione imperialistica del Regno sulla penisola balcanica fu promosso dai fascisti, che puntavano a appropriarsi di tutti i beni e a alimentare una continua avversione tra i diversi popoli jugoslavi, facendo risultare l'Italia come l'unica entità in grado di portare la pace. I fascisti croati furono addestrati al terrorismo e alla violenza per raccogliere consensi e perpetrare una persecuzione sociale ed economica, sottraendo le terre ai contadini che si ritrovarono sul lastrico.

In Italia e in zone occupate dal Regno, si iniziano ad aprire campi di internamento per slavi, adibiti a lavori forzati e smistamento. Furono circa 150.000 le persone rinchiuse per portare a compimento il progetto di bonifica nazionale, come stava facendo Hitler con gli ebrei in Germania, in un piano però non ben organizzato che non riuscì completamente nel suo intento. Un esempio fu il campo di Gonars, costruito appena fuori dall’abitato della provincia di Udine, costituito da due distinti recinti a circa un chilometro uno dall’altro, circondati da un alto filo spinato, con torrette di guardia con mitragliatrici e potenti fari che lo illuminavano a giorno. Qui furono internate, già nell'estate del 1942, 6.500 persone, deportate prima dalla città di Lubiana e poi da altre zone della Slovenia. Al momento della liberazione si contarono 500 morti di fame e malattia, 71 dei quali erano bambini di meno di un anno.
Il più esteso e popolato campo di concentramento fascista fu istallato con grande rapidità sull'isola di Arbe nel luglio del 1942, imprigionando sloveni, croati ed ebrei in pessime condizioni. In meno di un anno di funzionamento perirono 1.500 persone. Una realtà, quella dei lager, che caratterizzò tutta la penisola e che, in un anno di funzionamento, portarono alla morte di un numero di persone compreso tra 7 e 11.000, in condizioni crudeli e disumane.
Questo argomento ha rappresentato per decenni un tabù da non nominare e discutere, negli ultimi anni, con un maggiore studio dei campi di concentramento, si è fatta sempre più luce su avvenimenti a tanti non conosciuti. Il discorso verrà concluso dalla saggista nella serata di martedì 11 febbraio per completare il quadro di crimini e vicende che ha portato al dramma delle Foibe.
Una data riconosciuta dalla Repubblica con la Legge del 30 marzo 2004 come “Giorno del Ricordo”: “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.
Nella serata di martedì 4 febbraio Progetto Osnago e il Comune hanno avviato un percorso diviso in due incontri per approfondire il momento più cruento e disumano dei decenni di contrasti sul confine orientale. La saggista Alessandra Kersevan, con l'aiuto del collaboratore ISREC Gabriele Fontana, ha iniziato il discorso facendo una panoramica dei maggiori eventi che tra la prima e seconda Guerra Mondiale, hanno portato alla rottura dei rapporti di pace con i popoli confinanti ad est. Prima della Prima Guerra Mondiale i territori intorno al Friuli Venezia Giulia facevano parte dell'impero Austro Ungarico, una zona multietnica e multi linguista in stretto rapporto con il popolo italiano su un confine anch'esso molto variegato, una comunanza distrutta con l'avvento dell'ideologia nazionalista.
Alessandra Kersevan e Paolo Strina
Durante il primo conflitto mondiale erano già iniziate le prime deportazioni e i primi campi profughi per italiani di origine austro-ungarica che erano sospettati di schierarsi con i nemici, così come quando gli italiani invasero i territori jugoslavi, ampliando di molto il confine del regno ad est, imprigionarono individui che potevano rappresentare una minaccia. 500.000 mila persone di nazionalità norrena e croata furono inglobati dall'Italia, che avviò una campagna di “italianizzazione”, senza rispetto per la cultura e la libertà di questi popoli che venivano considerati poco affidabili. Con l'avvento del fascismo questi territori furono martoriati per il forte sentimento razzista verso gli slavi, furono colpite figure e luoghi simbolici, come il Narodni Dom, la casa della cultura slovena a Trieste, distrutta il 13 luglio 1920, ci furono repressioni poliziesche e giudiziarie, con condanne a morte degli oppositori del regime.
Paolo Strina e Gabriele Fontana
Iniziò un processo di italianizzazione dei toponimi e dei cognomi, venne inoltre bandito da tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento nelle lingue slave e vennero sciolte tutte le organizzazioni economiche, le associazioni culturali e professionali slovene. Violenta fu la reazione delle organizzazioni indipendentiste e terroriste slovene, tra cui il TIGR, acronimo di Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, per il risorgimento dei loro popoli e la fine dell'oppressione italiana. La repressione italiana verso questi popoli si acuì sempre di più, fino a sfociare nell'occupazione della Jugoslavia il 6 aprile 1941, sostenuta dalla Germania che bombardò Belgrado.
L'espansione imperialistica del Regno sulla penisola balcanica fu promosso dai fascisti, che puntavano a appropriarsi di tutti i beni e a alimentare una continua avversione tra i diversi popoli jugoslavi, facendo risultare l'Italia come l'unica entità in grado di portare la pace. I fascisti croati furono addestrati al terrorismo e alla violenza per raccogliere consensi e perpetrare una persecuzione sociale ed economica, sottraendo le terre ai contadini che si ritrovarono sul lastrico.
In Italia e in zone occupate dal Regno, si iniziano ad aprire campi di internamento per slavi, adibiti a lavori forzati e smistamento. Furono circa 150.000 le persone rinchiuse per portare a compimento il progetto di bonifica nazionale, come stava facendo Hitler con gli ebrei in Germania, in un piano però non ben organizzato che non riuscì completamente nel suo intento. Un esempio fu il campo di Gonars, costruito appena fuori dall’abitato della provincia di Udine, costituito da due distinti recinti a circa un chilometro uno dall’altro, circondati da un alto filo spinato, con torrette di guardia con mitragliatrici e potenti fari che lo illuminavano a giorno. Qui furono internate, già nell'estate del 1942, 6.500 persone, deportate prima dalla città di Lubiana e poi da altre zone della Slovenia. Al momento della liberazione si contarono 500 morti di fame e malattia, 71 dei quali erano bambini di meno di un anno.
Il più esteso e popolato campo di concentramento fascista fu istallato con grande rapidità sull'isola di Arbe nel luglio del 1942, imprigionando sloveni, croati ed ebrei in pessime condizioni. In meno di un anno di funzionamento perirono 1.500 persone. Una realtà, quella dei lager, che caratterizzò tutta la penisola e che, in un anno di funzionamento, portarono alla morte di un numero di persone compreso tra 7 e 11.000, in condizioni crudeli e disumane.
Questo argomento ha rappresentato per decenni un tabù da non nominare e discutere, negli ultimi anni, con un maggiore studio dei campi di concentramento, si è fatta sempre più luce su avvenimenti a tanti non conosciuti. Il discorso verrà concluso dalla saggista nella serata di martedì 11 febbraio per completare il quadro di crimini e vicende che ha portato al dramma delle Foibe.
I.BI.