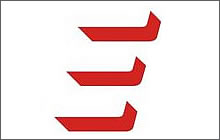LIBRI CHE RIMARRANNO/83: 'Oblio e perdono', l'ultimo romanzo di Harris
Prima della ghigliottina che fece cadere teste reali durante la Rivoluzione francese fu di un re inglese, Carlo I, la prima testa che rotolò, staccata dalla mannaia del boia il 30 gennaio 1649. Il tentativo repubblicano di Cromwell sfumò ben presto, e un secondo Carlo, figlio del re giustiziato, salì al trono. Adesso che ce n’è un terzo (fatti i debiti scongiuri non è più tempo di fini così cruente), lo scrittore inglese Robert Harris esce con questo corposo romanzo storico che racconta proprio quegli anni.
Nel luglio del 1660 due uomini laceri e consunti approdano sulle coste del Massachusetts: sono Edward Whalley e il genero William Goffee, ex colonnelli del New Model Army di Cromwell, firmatari insieme ad altri cinquantasette dignitari dell’atto di accusa e condanna di re Carlo I, e ora ricercati dai realisti, tornati al potere e decisi a fare giustizia. In base all’Atto di oblio (Act of oblivion è il titolo originale del romanzo che in Italia è “Oblio e perdono”, Mondadori 2022, pagg. 438, Euro 22,00) i cinquantanove regicidi sono stati giudicati colpevoli di alto tradimento. Cromwell è già morto ma tutti gli altri vengono inseguiti, catturati, impiccati, mutilati e sbudellati in modo orrendo. Tra i pochi riusciti a salvarsi in Olanda, in Germania o in Svizzera, i due colonnelli fuggiti in America vengono ospitati dalle piccole colonie puritane dei nuovi stati, in una perenne e pericolosa clandestinità.
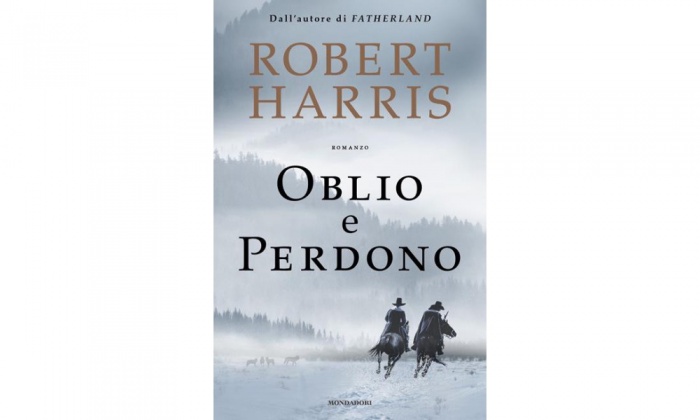
Sulle loro tracce un funzionario del Consiglio privato, Richard Nayler, si muove con una pervicacia che lascia interdetti persino i suoi superiori: irrazionale l’ostinazione, irragionevoli le spese, sproporzionate le forze messe in campo per la cattura di questi due fuggiaschi che già nell’esilio autoinflittosi, lontani dalle loro famiglie, avrebbero trovato una punizione bastevole.
Perché Nayler non si dà pace? Quale legame spiega questa sua ostinazione, che prosegue anche quando la società inglese ha dimenticato il regicidio ed è nauseata dalle esecuzioni così truculente degli ultimi catturati?
Il romanzo è una lunga, talora lenta, caccia all’uomo, oscillante tra i corridoi dei palazzi reali londinesi e la boscaglia di quella terra ubertosa e pericolosa che fu l’America per i coloni. La stessa ostinazione di Nayler pervade i due fuggiaschi, soprattutto il più giovane, William, convinto assertore delle teorie millenariste e fiducioso che il 1666 sarebbe stato l’anno ferale del Giudizio divino. È forse lui, più che Nayler, il personaggio centrale del romanzo: la sua fede puritana così tetragona pare non entrare mai in crisi nonostante le avversità e le angherie subite. Persino il suocero si distacca da queste certezze monolitiche, che risultano così anacronistiche per noi lettori moderni, secolarizzati e diffidenti. E infatti, se si salverà, la salvezza potrà venirgli da un’altra forza che muove il mondo, e che si chiama amore.
È dai tempi del bellissimo “Conclave” che Harris però, purtroppo, non fa centro con i suoi libri. L’autore di capolavori come “Fatherland”, della trilogia su Cicerone, di “Pompei”, o dell’”Ufficiale e la spia” sul caso Dreyfuss e di “The Ghostwriter” (dall’uno e dall’altro Polanski ha tratto film bellissimi), sembra aver esaurito non la materia, che nella storia non manca mai, ma l’ispirazione.
Anche quest’ultimo romanzo, purtroppo, non fa eccezione. Quel tono piano, avvolgente e mai urlato che era la cifra stilistica di Harris nei suoi capolavori, è diventato negli ultimi anni eccesso di didascalismo e citazionismo documentario. Il colpo di scena finale è davvero un po’ sprecato, tirato via in fretta, come un anticlimax prevedibile.
Attendo ancora, con fiducia, un nuovo colpo da maestro.
Nel luglio del 1660 due uomini laceri e consunti approdano sulle coste del Massachusetts: sono Edward Whalley e il genero William Goffee, ex colonnelli del New Model Army di Cromwell, firmatari insieme ad altri cinquantasette dignitari dell’atto di accusa e condanna di re Carlo I, e ora ricercati dai realisti, tornati al potere e decisi a fare giustizia. In base all’Atto di oblio (Act of oblivion è il titolo originale del romanzo che in Italia è “Oblio e perdono”, Mondadori 2022, pagg. 438, Euro 22,00) i cinquantanove regicidi sono stati giudicati colpevoli di alto tradimento. Cromwell è già morto ma tutti gli altri vengono inseguiti, catturati, impiccati, mutilati e sbudellati in modo orrendo. Tra i pochi riusciti a salvarsi in Olanda, in Germania o in Svizzera, i due colonnelli fuggiti in America vengono ospitati dalle piccole colonie puritane dei nuovi stati, in una perenne e pericolosa clandestinità.
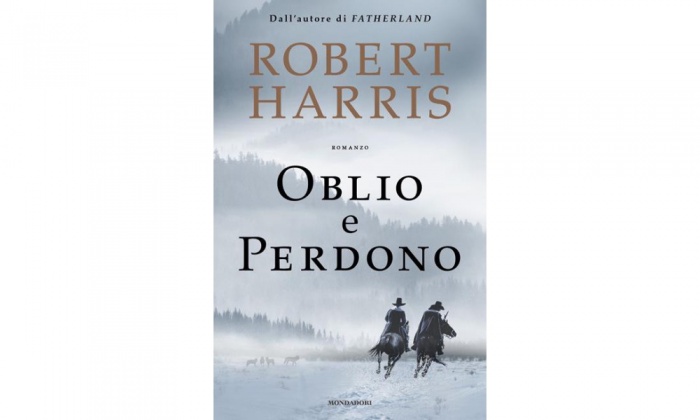
Perché Nayler non si dà pace? Quale legame spiega questa sua ostinazione, che prosegue anche quando la società inglese ha dimenticato il regicidio ed è nauseata dalle esecuzioni così truculente degli ultimi catturati?
Il romanzo è una lunga, talora lenta, caccia all’uomo, oscillante tra i corridoi dei palazzi reali londinesi e la boscaglia di quella terra ubertosa e pericolosa che fu l’America per i coloni. La stessa ostinazione di Nayler pervade i due fuggiaschi, soprattutto il più giovane, William, convinto assertore delle teorie millenariste e fiducioso che il 1666 sarebbe stato l’anno ferale del Giudizio divino. È forse lui, più che Nayler, il personaggio centrale del romanzo: la sua fede puritana così tetragona pare non entrare mai in crisi nonostante le avversità e le angherie subite. Persino il suocero si distacca da queste certezze monolitiche, che risultano così anacronistiche per noi lettori moderni, secolarizzati e diffidenti. E infatti, se si salverà, la salvezza potrà venirgli da un’altra forza che muove il mondo, e che si chiama amore.
È dai tempi del bellissimo “Conclave” che Harris però, purtroppo, non fa centro con i suoi libri. L’autore di capolavori come “Fatherland”, della trilogia su Cicerone, di “Pompei”, o dell’”Ufficiale e la spia” sul caso Dreyfuss e di “The Ghostwriter” (dall’uno e dall’altro Polanski ha tratto film bellissimi), sembra aver esaurito non la materia, che nella storia non manca mai, ma l’ispirazione.
Anche quest’ultimo romanzo, purtroppo, non fa eccezione. Quel tono piano, avvolgente e mai urlato che era la cifra stilistica di Harris nei suoi capolavori, è diventato negli ultimi anni eccesso di didascalismo e citazionismo documentario. Il colpo di scena finale è davvero un po’ sprecato, tirato via in fretta, come un anticlimax prevedibile.
Attendo ancora, con fiducia, un nuovo colpo da maestro.
Rubrica a cura di Stefano Motta