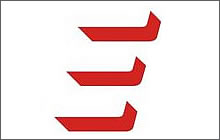LIBRI CHE RIMARRANNO/75: 2 casi per
il commissario Mario Mandelli di Cerone

"Sembra interessante... Ma scusa, tu come diavolo fai a sapere cosa succede a Merate?"
"Ti sei dimenticato dei nostri amici calabresi? Quello era il loro territorio, no?"
Era dai tempi del folle e geniale "Osnangeles" di Francesco Mandelli (Baldini&Castoldi, 2014) che Merate non compariva su un romanzo di spessore, di diffusione e successo nazionale: non me ne vogliano gli autori locali meratesi ma qui siamo di fronte a un libro che lascerà tracce.
Non è la prima volta che in questa nostra rubrica battezziamo dei titoli che poi la stampa nazionale e le giurie dei premi letterari celebrano e riconoscono come d'assoluto valore. Il passo che ho citato in apertura è tratto dal romanzo d'esordio di Gian Andrea Cerone "Le notti senza sonno" (Guanda 2022, pagg. 567, Euro 19,00), che è perlopiù ambientato a Milano, ma che non ho resistito a far comparire con queste righe in una rubrica che si pubblica proprio su una testata meratese.
Da venerdì 21 e venerdì 28 febbraio il commissario Mario Mandelli (un altro Mandelli!) dell'Unità di Analisi del Crimine Violento, un cinquantacinquenne solido, una vecchia volpe del mestiere, si trova a dover risolvere due casi sfuggenti: il ritrovamento di una mano amputata e due bulbi oculari in un cassonetto dell'immondizia di periferia, e una rapina plurimilionaria in una gioielleria del centro, con annesso omicidio del proprietario, tipico esponente della Milano bene ed ex Milano da bere.
Si tratta di due casi apparentemente agli antipodi, e che vanno risolti in fretta. Perché non è un febbraio qualunque, è il 2020, e in Questura l'unica cosa chiara, nella nebbia degli indizi contrastanti su questi due casi, è che da lì a pochissimo si chiuderà tutto per un altro intruso più pericoloso e sfuggente di qualsiasi serial killer psicopatico: il "casinovirus", come lo chiamano. Il Covid.
Mandelli e la sua squadra si muovono con decisione hollywoodiana e premura lombarda. È un giallo, classico, bello, che si legge con piacere e dal quale vorrei non ricavare chissà quale morale per una presunta eterogenesi dei fini che presiederebbe alla stesura di ogni libro. Ci sono scrittori che scrivono anche solo per il piacere di raccontare senza la pretesa cervellotica di insegnare. E di solito sono i migliori.
La quarta di copertina che ne annuncia lo stile "cinematografico" ha, per una volta, ragione.
Faccio un esempio, così si capisce quello che vuol dire una definizione usata spesso a sproposito e per decine di romanzi: c'è una scena in cui una Honda CBR Fireblade percorre tirando le marce le vie buie della Milano notturna. La narrazione si concentra sui gesti del pilota, sul suo abbigliamento, sulla visiera del casco integrale e sul polso destro che frusta l'acceleratore per alzare di giri il motore. E sulla Glock nascosta nella tasca interna della giacca. Quando smonta e toglie il casco si scopre che in realtà il pilota - raccontato esattamente al maschile, che in italiano è anche neutro, con buona pace di chi violenta la lingua di Dante con "avvocata", "assessora", "pilotessa" e altre sciocchezze - è una donna, una poliziotta, e corre all'impazzata non per compiere ma per sventare un delitto.
Tutto il romanzo è costruito così, con questo meccanismo di focalizzazione zero, abbassando il punto di vista, la telecamera, al livello dell'azione che si sta svolgendo, inseguendo gli attori (in narratologia si chiamano "attanti" ma ci si capisce) stando loro mezzo passo dietro, percependo le cose mentre loro stessi le vedono, passandogli talvolta davanti per inquadrarli e capire chi sono.
Succede anche nei dialoghi, in cui l'uso dei pronomi impersonali, spesso degli indefiniti, lascia aperte infinite possibilità di interpretazione su chi siano le due voci parlanti.
Qualche pagina dopo, il numero giusto di pagine perché il lettore si ricordi di quello scambio e sia ancora curioso, vengono svelati i retroscena. E pazienza se il lettore l'aveva già sospettato che le cose stessero così: quando ne trova conferma si sente lui stesso parte compiaciuta e attiva dell'indagine.
Ho iniziato questo romanzo con qualche sussiego nei confronti di alcune scelte che mi sembravano troppo scontate o molto furbe: l'agente Santosuso imbranato e comico come il Catarella di Montalbano o il D'Intino di Rocco Schiavone, l'anatomopatologo forense Bencivenni, toscano come il Fumagalli di Schiavone e pingue come il dottor Pasquano di Montalbano. Persino la classifica dei fastidi all'interno del commissariato, che classifica al grado "Bones 22" il caso del macabro ritrovamento, sembrava ricalcata sulla hit parade delle "rotture di coglioni" del vicequestore di Aosta Rocco Schiavone.
Ma poi il romanzo prende una sua voce, e non è quella dei protagonisti principali. È piuttosto quella di Marisa Bonacina in Mandelli, moglie del protagonista, affettuosa e intelligente, paziente ma tenace, in una parola: buona.
Lo chiama per cognome lei, "il suo Mandelli", e rappresenta, per lui che è immerso quotidianamente nelle più bieche aberrazioni del Male, quel porto sicuro di Bene che gli permette di fare il suo mestiere, e di farlo bene.
Come al solito, quando recensisco un giallo, cerco mille scuse per parlare di altro, perché svelare tanto è un'offesa alle fatiche dello scrittore e al piacere del lettore. Dico però che questo primo romanzo di Cerone appartiene a quella ridottissima categoria di libri che fanno desiderare che ve ne sia un secondo, e poi un terzo, e poi un altro ancora. Non perché si concluda con un finale aperto (le tessere dei due casi vanno ciascuna al posto giusto e tutto è chiaro), ma perché farebbe piacere passare ancora del tempo insieme a Mario Mandelli e sua moglie Marisa.
PER LEGGERE LE RECENSIONI PRECEDENTI CLICCA QUI