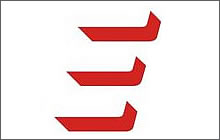LIBRI CHE RIMARRANNO/64: la montagna che soffre nel romanzo di Matteo Righetto
In questi giorni ho più corde e moschettoni che libri nello zaino. Giro per le pareti dolomitiche arrampicandosi con mio figlio grande e leggendo il libro della Natura e il più misterioso libro dell'adolescenza nei suoi occhi e nei suoi silenzi.

I miei lettori mi capiranno se scelgo perciò di riproporre una recensione di un po' di tempo fa.
Il romanzo di cui parla racconta di una montagna con l'ultima neve in sofferenza, di un caldo che divora le pianure, e di un uomo buono e incompreso che cerca una salvezza per tutti.
L'ha scritto un amico, che vive in Dolomiti e dalle sue finestre vede ogni giorno la Marmolada.
La letteratura talora sa essere visionaria e profetica, e in questo caso però si spera non lo sia stata.

I miei lettori mi capiranno se scelgo perciò di riproporre una recensione di un po' di tempo fa.
Il romanzo di cui parla racconta di una montagna con l'ultima neve in sofferenza, di un caldo che divora le pianure, e di un uomo buono e incompreso che cerca una salvezza per tutti.
L'ha scritto un amico, che vive in Dolomiti e dalle sue finestre vede ogni giorno la Marmolada.
La letteratura talora sa essere visionaria e profetica, e in questo caso però si spera non lo sia stata.
Avrei voluto che la recensione di questo romanzo aprisse, per prima, questa mia rubrica settimanale. Mi spingeva l'amicizia con Matteo. Mi ha frenato una sensazione inattesa, che mi ha impedito per giorni e giorni di proseguire oltre pagina 32.
Ho letto tantissimo nella mia non poi così lunga vita, ho spiegato più libri di quanti forse abbia davvero letto, ho scritto qualcosina, eppure mai mi era capitato di sentirmi tremare il mento leggendo. È quella percezione netta di una bontà ingenua e pulitissima, di un'innocenza primordiale che traluce dal personaggio di Bruno, la figura più buona della letteratura che ho sinora frequentato, e ne ho frequentata.
Una volta si sarebbe definito lo scemo del paese, di quei paesi di montagna dove il cretinismo era una malattia endemica, perché il primo dei tre personaggi protagonisti de "I prati dopo di noi" (Feltrinelli, 2020, 2020, pagg. 172) vive nella baita avita in alta montagna, alle pendici di un Ortles tanto vero quanto trasfigurato dalla fantasia ucronica e distopica di Matteo. E come tutti i sempliciotti è grande, e grosso. "E ciula", si direbbe qui giù da me in città, dove la lentezza è un difetto, l'innocenza un peccato, la mansuetudine una malattia.
Bruno si trova a vivere in un monastero, fedele custode degli apiari, così importanti per la produzione del miele pregiato, della propoli medicamentosa, dell'idromele e della cera per le candele, e lui, così grande, si prende cura delle api, esseri piccolissimi e indispensabili per la natura, le ultime api del mondo.
Mentre il mondo in pianura è devastato dagli incendi, e fumo e fuoco risalgono inesorabili le pendici degli ultimi luoghi incontaminati, Bruno parte con le sue api per portarle al riparo, dove ancora si conservano le ultime nevi.
Parte dal suo paese anche il vecchio Johannes, che ha tagliato l'ultimo abete e con il suo legno ha costruito una bara, che ora trasporta sul suo carro.
Vaga solitaria e incrocia Bruno anche la piccola Leni, orfana, sordomuta, una specie di Bruno in miniatura che del gigante condivide sorte e lingua, quella silenziosa della bontà.
C'è un po' di Huck Finn e di Cosimo Piovasco Barone di Rondò in Leni, un po' di Mark Twain e un po' di Calvino. C'era Cormac Mc Carthy nella "trilogia della frontiera" che Righetto ha pubblicato con Mondadori negli anni passati e questo romanzo Feltrinelli ne è, per certi versi, più una palingenesi che un'appendice. E c'è Sergio Leone, anche, o E. B. Clucher, nell'atmosfere western del vecchio che va di paese in paese portando una bara sul carretto e chiedendo alloggio nelle povere locande, tra gli sguardi dubbiosi e scaramantici dei pochi disillusi avventori. C'è Bergman nel suo sfidare i presenti a dama, per guadagnarne vitto e alloggio, per trovare chi lo sconfigga e capire se sia davvero giunta l'ora. Non è difficile immaginare chi, alla fine, potrà mettere il sigillo alla partita, e sarà un sigillo buono.
Non ci sono leoni rifiniti e maceri dall'inedia né tempeste di sabbia a chiudere questa operetta morale di Matteo. Ci sono le api, e una Natura che non si arrende.
E i nostri occhi che non potranno essere gli stessi quando guarderanno la pioggia, la neve, il sole, le foglie, dopo questo romanzo.
Se sono bastati pochi mesi di lockdown - ché a noi sono sembrati e continuano ad apparire un'eternità, ma nei tempi della Natura sono stati un battito di ciglia - a far riapparire daini e cervi in valle, lepri in città, e sgombrare il cielo di nuvole pestilenziali, e far nevicare in città a inizio dicembre, vuol dire che nulla è ancora definitivamente scritto.
Ah, se non servisse per forza la paura, ma bastasse solo essere buoni...
Ho letto tantissimo nella mia non poi così lunga vita, ho spiegato più libri di quanti forse abbia davvero letto, ho scritto qualcosina, eppure mai mi era capitato di sentirmi tremare il mento leggendo. È quella percezione netta di una bontà ingenua e pulitissima, di un'innocenza primordiale che traluce dal personaggio di Bruno, la figura più buona della letteratura che ho sinora frequentato, e ne ho frequentata.
Una volta si sarebbe definito lo scemo del paese, di quei paesi di montagna dove il cretinismo era una malattia endemica, perché il primo dei tre personaggi protagonisti de "I prati dopo di noi" (Feltrinelli, 2020, 2020, pagg. 172) vive nella baita avita in alta montagna, alle pendici di un Ortles tanto vero quanto trasfigurato dalla fantasia ucronica e distopica di Matteo. E come tutti i sempliciotti è grande, e grosso. "E ciula", si direbbe qui giù da me in città, dove la lentezza è un difetto, l'innocenza un peccato, la mansuetudine una malattia.
Bruno si trova a vivere in un monastero, fedele custode degli apiari, così importanti per la produzione del miele pregiato, della propoli medicamentosa, dell'idromele e della cera per le candele, e lui, così grande, si prende cura delle api, esseri piccolissimi e indispensabili per la natura, le ultime api del mondo.
Mentre il mondo in pianura è devastato dagli incendi, e fumo e fuoco risalgono inesorabili le pendici degli ultimi luoghi incontaminati, Bruno parte con le sue api per portarle al riparo, dove ancora si conservano le ultime nevi.
Parte dal suo paese anche il vecchio Johannes, che ha tagliato l'ultimo abete e con il suo legno ha costruito una bara, che ora trasporta sul suo carro.
Vaga solitaria e incrocia Bruno anche la piccola Leni, orfana, sordomuta, una specie di Bruno in miniatura che del gigante condivide sorte e lingua, quella silenziosa della bontà.
C'è un po' di Huck Finn e di Cosimo Piovasco Barone di Rondò in Leni, un po' di Mark Twain e un po' di Calvino. C'era Cormac Mc Carthy nella "trilogia della frontiera" che Righetto ha pubblicato con Mondadori negli anni passati e questo romanzo Feltrinelli ne è, per certi versi, più una palingenesi che un'appendice. E c'è Sergio Leone, anche, o E. B. Clucher, nell'atmosfere western del vecchio che va di paese in paese portando una bara sul carretto e chiedendo alloggio nelle povere locande, tra gli sguardi dubbiosi e scaramantici dei pochi disillusi avventori. C'è Bergman nel suo sfidare i presenti a dama, per guadagnarne vitto e alloggio, per trovare chi lo sconfigga e capire se sia davvero giunta l'ora. Non è difficile immaginare chi, alla fine, potrà mettere il sigillo alla partita, e sarà un sigillo buono.
Non ci sono leoni rifiniti e maceri dall'inedia né tempeste di sabbia a chiudere questa operetta morale di Matteo. Ci sono le api, e una Natura che non si arrende.
E i nostri occhi che non potranno essere gli stessi quando guarderanno la pioggia, la neve, il sole, le foglie, dopo questo romanzo.
Se sono bastati pochi mesi di lockdown - ché a noi sono sembrati e continuano ad apparire un'eternità, ma nei tempi della Natura sono stati un battito di ciglia - a far riapparire daini e cervi in valle, lepri in città, e sgombrare il cielo di nuvole pestilenziali, e far nevicare in città a inizio dicembre, vuol dire che nulla è ancora definitivamente scritto.
Ah, se non servisse per forza la paura, ma bastasse solo essere buoni...
Rubrica a cura di Stefano Motta