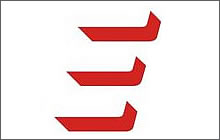LIBRI CHE RIMARRANNO/61: 'Poco a me stesso', il romanzo di Alessandro Zaccuri
“Poco a me stesso” di Alessandro Zaccuri (Marsilio, 2022, pagg. 234, euro 16,00) è un romanzo interessante.
In copertina il particolare del quadro di Caravaggio “I bari” dovrebbe avvertirci che tutto al suo interno è trucco e finzione.
Lo è l’impostura di una specie di Dorian Gray franco meneghino, il barone di Cerclefleury, ottantenne conservatosi trentenne grazie alle mirabilie del magnetismo animale di Mesmer; lo è quella dell’ormai anziana marchesa Giulia Beccaria e lo è quella, a tratti inconsapevole, del suo contabile, Evaristo Tirinnanzi, cognome ricalcato sul nome di un bravaccio manzoniano, il Tiradritto, carattere e tic modellati su quelli del don Lisander, fattezze fisiche pure.
“Ombroso all’apparenza e incline alla balbuzie. Non brutto d’aspetto, per quanto il volto risentisse di un che di appuntito e slungato non infrequente tra le genti di Lombardia […] un nono so che di minaccioso, come di una furia trattenuta a stento sotto un velo sottile di mitezza e sottomissione”, scrive Zaccuri a pag. 15.
“Un’ombra squisita ed elegante” definiva Manzoni il Momigliano. E lui stesso di sé diceva in un sonetto giovanile:
“Capel bruno, alta fronte, occhio loquace, / Naso non grande e non soverchio umìle, / Tonda la gota e di color vivace, / Stretto labbro e vermiglio, e bocca esìle; […] Giovin d’anni e di senno, non audace, / Duro di modi, ma di cor gentile […] / Poco noto ad altrui, poco a me stesso, / Gli uomini e gli anni mi diran chi sono.”

Zaccuri parte da un’idea geniale, una sliding door fervida di suggestioni: cosa sarebbe stato del figlio dell’amore passionale e passeggero di Giulia Beccaria e Giovanni Verri se lei non fosse stata sposa del vecchio Pietro Manzoni (che si sappia per tutti quelli che ancora non lo sanno: Alessandro Manzoni non è figlio del conte Pietro perché il suddetto conte era privo di testicoli e non poteva generare. Lo riconobbe come suo e da lì in poi vie, scuole, strade, ospedali, biblioteche, teatri prendono il nome da quell’inganno a fin di bene)? Sarebbe diventato lo scrittore che tutti conosciamo? Il “genio” che lo animava è stato alimentato da quella sua condizione sociale così particolare o sarebbe sbocciato comunque?
A pag. 89 il Tirinnanzi consegna al Cerclefleury un suo quaderno (poteva mancare un manoscritto quasi anonimo?), uno scartafaccio denso di appunti e frasi apparentemente slegate e senza senso: “C’erano trecce morbide che si posavano su aride sponde, massi in equilibrio sul vertice di non si sa qual erta montana e sventurate che rispondevano, Alpi e piramidi, atri muscosi, un confluire di fiumi d’ogni terra e paese (l’Adda, il Reno, il Manzanarre, il Ticino), e poi monache e briganti, sventure che si volevano provvide, motti latini lasciati a mezzo, esortazioni raffazzonate nella parlata degli spagnoli…”. Senza senso per il Cerclefleury, ma noi che abbiamo fatto le scuole ci riconosciamo Ermengarda e “Marzo 1821”, “Il Natale” e anche “Il Natale del 1833” (il motto latino “cecidere manus”), “Il Cinque Maggio” e il coro del “Carmagnola” e la sventurata che rispose e via discorrendo.
Torno a dire: questo romanzo ha materia di prima scelta.
I grandi cuochi sanno che quando hai materie prime di così gran valore le devi cucinare quasi in purezza, senza coprirle di aromi e profumi e contorni che le anneghino in uno sperimentalismo compiaciuto.
Anche i grandi scrittori lo sanno.
L’idea geniale di questo romanzo è invece soffocata da trovate un po’ ridicole (tra i nomi della servitù compaiono un’Agnese, un Menico, un Attilio, suvvia!), reminiscenze erudite ma inutili alla trama (l’eccidio del Prina) e colpi di scena più fogazzariani che manzoniani (il cassetto segreto!) che sono la via d’uscita ormai obbligata con cui alla fine il narratore rivela ciò che il lettore ha già capito da un pezzo.
Anche il colpo di scena finale dei bauli del Cerclefleury finalmente recapitati da un postiglione tedesco (fa molto “Conte di Montecristo”) è un po’ sprecato. E la “fuitina” poi (mi taccio per non svelare troppo)!
Un po’ Dickens, un po’ Balzac, un po’ Dumas, un po’ Fogazzaro, un po’ Eco (il “doppio” pare un clone del protagonista dell’”Isola del giorno prima”): troppe spezie a condire qualcosa che forse andava cucinato con maggior purezza e coraggio.
Eppure non riesco a non consigliarne la lettura: pur aperta maldestramente, pur scricchiolante, quella sliding door ha un fascino che deve rendere merito a chi ha avuto il coraggio di infilare la chiave nella toppa piuttosto che sbirciare solo dal buco della serratura.
In copertina il particolare del quadro di Caravaggio “I bari” dovrebbe avvertirci che tutto al suo interno è trucco e finzione.
Lo è l’impostura di una specie di Dorian Gray franco meneghino, il barone di Cerclefleury, ottantenne conservatosi trentenne grazie alle mirabilie del magnetismo animale di Mesmer; lo è quella dell’ormai anziana marchesa Giulia Beccaria e lo è quella, a tratti inconsapevole, del suo contabile, Evaristo Tirinnanzi, cognome ricalcato sul nome di un bravaccio manzoniano, il Tiradritto, carattere e tic modellati su quelli del don Lisander, fattezze fisiche pure.
“Ombroso all’apparenza e incline alla balbuzie. Non brutto d’aspetto, per quanto il volto risentisse di un che di appuntito e slungato non infrequente tra le genti di Lombardia […] un nono so che di minaccioso, come di una furia trattenuta a stento sotto un velo sottile di mitezza e sottomissione”, scrive Zaccuri a pag. 15.
“Un’ombra squisita ed elegante” definiva Manzoni il Momigliano. E lui stesso di sé diceva in un sonetto giovanile:
“Capel bruno, alta fronte, occhio loquace, / Naso non grande e non soverchio umìle, / Tonda la gota e di color vivace, / Stretto labbro e vermiglio, e bocca esìle; […] Giovin d’anni e di senno, non audace, / Duro di modi, ma di cor gentile […] / Poco noto ad altrui, poco a me stesso, / Gli uomini e gli anni mi diran chi sono.”
Di Manzoni questo Tirinnanzi ha la balbuzie, l’agorafobia, la passione per le lunghe passeggiate. Di alcuni tra i figli di Manzoni ha il vizio per il gioco delle carte e dei dadi. Rispetto al vero Manzoni pare avere più talento per i numeri, giacché Zaccuri ce lo presenta come il contabile della marchesa Giulia Beccaria, e invece come ognun sa Manzoni non è che avesse proprio il talento per gli affari, anzi.

A pag. 89 il Tirinnanzi consegna al Cerclefleury un suo quaderno (poteva mancare un manoscritto quasi anonimo?), uno scartafaccio denso di appunti e frasi apparentemente slegate e senza senso: “C’erano trecce morbide che si posavano su aride sponde, massi in equilibrio sul vertice di non si sa qual erta montana e sventurate che rispondevano, Alpi e piramidi, atri muscosi, un confluire di fiumi d’ogni terra e paese (l’Adda, il Reno, il Manzanarre, il Ticino), e poi monache e briganti, sventure che si volevano provvide, motti latini lasciati a mezzo, esortazioni raffazzonate nella parlata degli spagnoli…”. Senza senso per il Cerclefleury, ma noi che abbiamo fatto le scuole ci riconosciamo Ermengarda e “Marzo 1821”, “Il Natale” e anche “Il Natale del 1833” (il motto latino “cecidere manus”), “Il Cinque Maggio” e il coro del “Carmagnola” e la sventurata che rispose e via discorrendo.
Torno a dire: questo romanzo ha materia di prima scelta.
I grandi cuochi sanno che quando hai materie prime di così gran valore le devi cucinare quasi in purezza, senza coprirle di aromi e profumi e contorni che le anneghino in uno sperimentalismo compiaciuto.
Anche i grandi scrittori lo sanno.
L’idea geniale di questo romanzo è invece soffocata da trovate un po’ ridicole (tra i nomi della servitù compaiono un’Agnese, un Menico, un Attilio, suvvia!), reminiscenze erudite ma inutili alla trama (l’eccidio del Prina) e colpi di scena più fogazzariani che manzoniani (il cassetto segreto!) che sono la via d’uscita ormai obbligata con cui alla fine il narratore rivela ciò che il lettore ha già capito da un pezzo.
Anche il colpo di scena finale dei bauli del Cerclefleury finalmente recapitati da un postiglione tedesco (fa molto “Conte di Montecristo”) è un po’ sprecato. E la “fuitina” poi (mi taccio per non svelare troppo)!
Un po’ Dickens, un po’ Balzac, un po’ Dumas, un po’ Fogazzaro, un po’ Eco (il “doppio” pare un clone del protagonista dell’”Isola del giorno prima”): troppe spezie a condire qualcosa che forse andava cucinato con maggior purezza e coraggio.
Eppure non riesco a non consigliarne la lettura: pur aperta maldestramente, pur scricchiolante, quella sliding door ha un fascino che deve rendere merito a chi ha avuto il coraggio di infilare la chiave nella toppa piuttosto che sbirciare solo dal buco della serratura.
Rubrica a cura di Stefano Motta