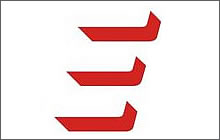LIBRI CHE RIMARRANNO/56: Righetto e ''La stanza delle mele'' con Giacomo Nef

Quella di Giacomo Nef, undici anni, ultimo di tre fratelli orfani allevati dai nonni materni, è il deposito delle mele selvatiche dove il nonno lo rinchiude spesso per castigo, dopo averlo severamente punito.
Quella di Giacomo Nef, scultore di fama internazionale, è il suo laboratorio in una calle di Venezia, dove custodisce l'opera che chiuderà il cerchio della sua ricerca esistenziale più che artistica.
Il profumo delle mele e del legno si mescolano in questo romanzo di Matteo Righetto ("La stanza delle mele", Feltrinelli, 2022, pagg. 231, Euro 18,00), dolciastri e pungenti entrambi come pungente è la sua prosa.
Righetto ci porta nel 1954 a Daghè, "tre case, tre fienili, tre famiglie", minuscola frazione di Livinallongo aggrappata alle pendici del Col di Lana. Chi conosce la storia sa l'importanza strategica di quella montagna, così contesa durante la Grande Guerra proprio per la sua posizione centrale rispetto alle vallate dolomitiche. Chi conosce quelle montagne sa la potenza che quei boschi nascondono in sé, e il fascino di quelle pareti visibili fin da Venezia (città di mare che si regge proprio sui tronchi delle conifere di quei boschi!), incendiate da tramonti rosa che non esistono in nessuna altra parte del mondo. La Marmolada, le creste vulcaniche del Padon, il massiccio tozzo del Sella, i campanili del Civetta, lo slancio insolito del Lagazuoi popolano gli occhi del giovane Giacomo, che un giorno sotto un tremendo temporale nel Bosch Negher trova un uomo impiccato.
Chi è quell'uomo? Possibile che il nonno, che ha mandato Giacomo a recuperare la roncola lasciata là, non l'abbia visto? A chi dirlo? Ai fratelli più grandi? In paese? Il terrore del bambino custodisce un segreto che la suggestione trasforma poi nella causa di una serie di eventi che lasciano Giacomo, Titta e Celestino, i fratelli, ancora più soli e dispersi.
Chiuso nella stanza delle mele Giacomo scopre la scultura come sollievo alle percosse del nonno e catarsi creativa, e sarà questa disciplina maieutica a farlo diventare non solo adulto ma grande. Il bambino Giacomo e l'artista Nef cercano infatti la risposta alla stessa domanda su quell'uomo impiccato: "Tornare lì in questo momento della mia carriera - dice Giacomo adulto alla sua gallerista - e poterci tornare proprio con quest'opera è tutto ciò che desidero. Non chiedo altro. Per me significa chiudere un cerchio".
"Ci sono cose che valgono più dei soldi", aveva imparato da ragazzo, girando col nonno e la nonna nelle valli ladine, accudendo la terra e gli animali, sognando che il Lagazuoi fosse il suo K2 (l'impresa di Lacedelli e Compagnoni è proprio del '54).
"La stanza delle mele" ha la voce incantata di questo ragazzo che sta imparando, suo malgrado, la lingua di un mondo in corsa verso la modernità. Righetto lo inonda di termini ladini, come radici non solo lessicali da cui non staccarsi, perché le cose più belle hanno nomi unici, ancestrali. Sono il "fistìl", l'abbeveratoio scavato in un tronco di larice, i "mader", le faine che attaccano il pollaio dei Nef, il "dorch", il fieno del secondo taglio stagionale, e così via. Ma il romanzo ha anche la voce inconfondibile di Righetto.
Matteo mi perdonerà se dico anzi che "ritrova" la voce inconfondibile della sua potentissima trilogia "della frontiera" pubblicata con Mondadori.
Quel che là era indeterminato, talora fiabesco, talaltra western, qui prende un nome e delle coordinate geografiche minuziose e quasi impudiche: se non si poteva localizzare la "Nevada" tra le Dolomiti e le Prealpi venete dove avevano la casa i De Boer, qui possiamo aprire Google Maps e risalire la strada "sinuosa come un orbettino" che da Pieve di Livinallongo porta ad Agai, la Daghè del romanzo.
Trovo che questo sia uno dei romanzi più belli tra i molti belli di Righetto e capisco che lui abbia parlato di sé stesso e di quell'arte, la scrittura, così simile alla scultura.
Quando gli ho scritto per fargli i complimenti ero tentato di chiederglielo: «Quanto c'è di autobiografico in queste pagine, Matteo?». Non l'ho fatto perché ci sono aspetti su cui uno scrittore ha un pudore particolare. Preferisco perciò comportarmi come un bravo critico deve fare, e indagare io tra le righe.
C'è quella descrizione di Colle Santa Lucia, dove Matteo vive, messa in bocca a un personaggio magico del romanzo, che diviene una spia del punto di vista dell'autore: "È un posto particolare, sai? Si possono vedere ben sei vallate: Codalonga, Fiorentina, Fodòm, Pettorina, Biois e Cordevole. Da nessun altro posto si possono vedere così tante valli dall'alto. Lì soffia sempre un vento che non ha nome, è il respiro di tutte le frontiere" (p. 99).
C'è il nome del fieno, "dorch", che con la maiuscola ha un significato particolare per Matteo che i suoi amici conoscono.
C'è la vigna inselvatichita eppure ancora fruttifera di Renzo Tramaglino quando Giacomo ritorna, adulto, in una Daghè abbandonata dagli uomini e riconquistata dalla natura. E io so quanto Righetto conosca e ami Manzoni.
C'è, credo, quella inesausta ricerca di senso che né la religione, né il denaro, né le leggende possono dare: "L'essere umano, più che dal bisogno, è mosso dal significato", dice Giacomo quasi alla fine del romanzo. È l'arte a permettere l'agnitio finale, che chiude il cerchio e manzonianamente salva.
PER LEGGERE LE RECENSIONI PRECEDENTI CLICCA QUI
Rubrica a cura di Stefano Motta