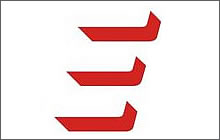LIBRI CHE RIMARRANNO/32: ''Italiana'' di Giuseppe Catozzella
Si dice spesso che nelle opere di narrazione i cattivi siano più interessanti dei buoni, perché più complessi, per molti aspetti persino più veri.
Cattiva per la giustizia savoiarda che aveva fatto l'Italia e stentava a fare gli italiani. Le italiane poi, meno ancora.
Le imprese di Ciccilla e di suo marito Pietro sulla Sila sono documentate nel Museo di Antopologia criminale di Torino, che custodisce due foto dei Maria appartenenti all'archivio di Cesare Lombroso, che nel romanzo la misura e la studia. E sulle pagine dell'"Indipendente", il giornale che Alexandre Dumas diresse tra il 1860 e il '64. In quello stesso anno abbozzò sette puntate di un romanzo sulla vita di Maria, che non completò. Finì invece un altro romanzo, che uscì però postumo nel '72: parlava di una banda di briganti che viveva nei boschi, e rubava ai ricchi per restituire ai poveri quel che un potere centrale stolto e violento aveva requisito. Come ognun sa si intitola "Robin Hood. Il principe dei ladri". Quel che qualcuno sa è che non può non essere ispirata alla storia di Pietro e Maria.
Catozzella cita Ippolito Nievo, testimone prezioso delle pagine di storia garibaldina. Dice di cercare in filigrana tra le sue pagine anche Camus, e Mario Rigoni Stern. E io ci vedo anche Verga, naturalmente. Nella prima parte, soprattutto, che è quella che più ho apprezzato.
Le pagine della storia dell'infanzia di Maria, della sua famiglia povera, di quel padre che si rompe la schiena e muore poi, piegato dai capricci della figlia maggiore andata a fare la signora in città, hanno qualcosa di verghiano, e le ho molto apprezzate. Più della seconda parte, quella della lotta brigantesca sui monti.
Mi tocca dire senza svelare, naturalmente, per non far torto a una storia che merita di essere letta e che corre al ritmo veloce di una prosa furba, ma ci sono alcuni personaggi felicissimi, che ho molto amato. Zia Terremoto, soprattutto, che viveva sui monti e puzzava dello stesso odore delle sue bestie: odore di lavoro, e di buono. E Teresa, la sorella maggiore che sarà il motore della vicenda drammatica di Maria. Quasi una presenza fantasmatica nelle prime pagine, e poi un pugnale affilato ogni volta che si affaccia nella storia. Se è vero che i cattivi sono più interessanti dei buoni, Teresa è una cattiva come raramente mi è capitato di leggere: chissà cosa avrebbe detto Lombroso se avesse potuto studiare la sua, di fisiognomica. Perché la perfidia che si nasconde sotto le vesti eleganti è affilatissima. E i vestiti di Teresa sono quanto di più elegante la gente del romanzo aveva mai visto.
Il romanzo inizia dalla quasi fine, con una prolessi (un flash forward dicono quelli che dicono di saper parlare bene) in perfetto stile "Butch Cassidy", e poi ritorna indietro come un lungo flusso di ricordi narrati in prima persona da Maria. Ci riallacciamo all'inizio a pagina 286, nel mezzo del corpo del racconto, e la scena che pure già conoscevamo ci colpisce di nuovo, ancora più straniante. Ma non è la fine: mancano ancora 31 pagine, ed è in quelle che si consuma il vero anelito di libertà di Maria, che "ha le tette!", grida il soldato quando la cattura: "Certo che non ero un uomo, per niente al mondo avrei voluto esserlo [...]. Ma una cosa deve essere chiara: se ho usato un coltello per tagliarmi i capelli e mi sono vestita da uomo non è stato per essere come uno di loro. Se l'ho fatto è stato perché, senza, non mi sarei mai liberata."
Parla bene, Ciccilla, che al processo si dichiara "illetterata" perché "con la legge, se sei soltanto una tessitrice, è meglio fingersi idioti."
Le parole le sa usare bene, invece, tanto e forse meglio del fucile e del coltello.
"Rimpiango di non essere stata più felice. La parola felicità da noi è vietata ma sapevo che esisteva, e avrei dovuto crederci. Quando manca il coraggio, troviamo la scusa che le parole sono soltanto parole. Invece sono armi per cambiare il mondo."
È un po' retorico, forse, come molte pagine del romanzo (l'ho detto che si tratta di una scrittura furba, che talora insegue l'aforisma), ma chi ha vissuto le sue grandi o piccole battaglie della vita sa che è vero.
La distinzione tra buoni e cattivi si paluda di connotati morali, o piuttosto è un postulato di una Storia scritta, inevitabilmente, dai vincitori.
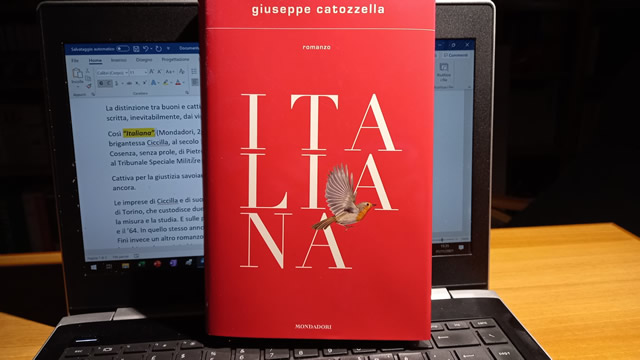
Cattiva per la giustizia savoiarda che aveva fatto l'Italia e stentava a fare gli italiani. Le italiane poi, meno ancora.
Le imprese di Ciccilla e di suo marito Pietro sulla Sila sono documentate nel Museo di Antopologia criminale di Torino, che custodisce due foto dei Maria appartenenti all'archivio di Cesare Lombroso, che nel romanzo la misura e la studia. E sulle pagine dell'"Indipendente", il giornale che Alexandre Dumas diresse tra il 1860 e il '64. In quello stesso anno abbozzò sette puntate di un romanzo sulla vita di Maria, che non completò. Finì invece un altro romanzo, che uscì però postumo nel '72: parlava di una banda di briganti che viveva nei boschi, e rubava ai ricchi per restituire ai poveri quel che un potere centrale stolto e violento aveva requisito. Come ognun sa si intitola "Robin Hood. Il principe dei ladri". Quel che qualcuno sa è che non può non essere ispirata alla storia di Pietro e Maria.
Catozzella cita Ippolito Nievo, testimone prezioso delle pagine di storia garibaldina. Dice di cercare in filigrana tra le sue pagine anche Camus, e Mario Rigoni Stern. E io ci vedo anche Verga, naturalmente. Nella prima parte, soprattutto, che è quella che più ho apprezzato.
Le pagine della storia dell'infanzia di Maria, della sua famiglia povera, di quel padre che si rompe la schiena e muore poi, piegato dai capricci della figlia maggiore andata a fare la signora in città, hanno qualcosa di verghiano, e le ho molto apprezzate. Più della seconda parte, quella della lotta brigantesca sui monti.
Mi tocca dire senza svelare, naturalmente, per non far torto a una storia che merita di essere letta e che corre al ritmo veloce di una prosa furba, ma ci sono alcuni personaggi felicissimi, che ho molto amato. Zia Terremoto, soprattutto, che viveva sui monti e puzzava dello stesso odore delle sue bestie: odore di lavoro, e di buono. E Teresa, la sorella maggiore che sarà il motore della vicenda drammatica di Maria. Quasi una presenza fantasmatica nelle prime pagine, e poi un pugnale affilato ogni volta che si affaccia nella storia. Se è vero che i cattivi sono più interessanti dei buoni, Teresa è una cattiva come raramente mi è capitato di leggere: chissà cosa avrebbe detto Lombroso se avesse potuto studiare la sua, di fisiognomica. Perché la perfidia che si nasconde sotto le vesti eleganti è affilatissima. E i vestiti di Teresa sono quanto di più elegante la gente del romanzo aveva mai visto.
Il romanzo inizia dalla quasi fine, con una prolessi (un flash forward dicono quelli che dicono di saper parlare bene) in perfetto stile "Butch Cassidy", e poi ritorna indietro come un lungo flusso di ricordi narrati in prima persona da Maria. Ci riallacciamo all'inizio a pagina 286, nel mezzo del corpo del racconto, e la scena che pure già conoscevamo ci colpisce di nuovo, ancora più straniante. Ma non è la fine: mancano ancora 31 pagine, ed è in quelle che si consuma il vero anelito di libertà di Maria, che "ha le tette!", grida il soldato quando la cattura: "Certo che non ero un uomo, per niente al mondo avrei voluto esserlo [...]. Ma una cosa deve essere chiara: se ho usato un coltello per tagliarmi i capelli e mi sono vestita da uomo non è stato per essere come uno di loro. Se l'ho fatto è stato perché, senza, non mi sarei mai liberata."
Parla bene, Ciccilla, che al processo si dichiara "illetterata" perché "con la legge, se sei soltanto una tessitrice, è meglio fingersi idioti."
Le parole le sa usare bene, invece, tanto e forse meglio del fucile e del coltello.
"Rimpiango di non essere stata più felice. La parola felicità da noi è vietata ma sapevo che esisteva, e avrei dovuto crederci. Quando manca il coraggio, troviamo la scusa che le parole sono soltanto parole. Invece sono armi per cambiare il mondo."
È un po' retorico, forse, come molte pagine del romanzo (l'ho detto che si tratta di una scrittura furba, che talora insegue l'aforisma), ma chi ha vissuto le sue grandi o piccole battaglie della vita sa che è vero.
Rubrica a cura di Stefano Motta