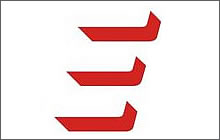LIBRI CHE RIMARRANNO/31: ''Ciò che nel silenzio non tace'' di Martina Merletti

Quante volte quello che non riesce ad essere taciuto ha generato pasticci?
Quante altre invece parlare di qualcosa si è rivelato liberatorio?
È in questo equilibrio di custodia e di svelamento che si gioca la vita di noi tutti, la storia di ciascuno e la Storia più grande.
È questa Storia che si intreccia, a passi sofferti, nelle pagine del bellissimo romanzo di Martina Merletti, che prende il titolo da un verso di Rilke, "Ciò che nel silenzio non tace" (Einaudi, pp. 262 , Euro 18,00).
La storia vera di suor Giuseppina De Muro, direttrice della sezione femminile del carcere torinese Le Nuove, dei suoi sforzi per lenire le sofferenze delle recluse, del gesto materno con cui, nell'estate del '44, addormenta il neonato di una prigioniera ebrea e lo fa uscire, di notte, nascosto in un fagotto di lenzuola sporche nel carrello della biancheria, novello Mosè salvato in una cesta di panni.
Di questo bambino si perdono subito le tracce, a pagina 5, mentre ci si immerge nella vita anonima, contadina e buona, di un paese della campagna e dei suoi campi di girasole. La Storia si fa minuscola, dialettale, e pudica.
E poi riaffiora nelle ricerche della giovane Aila Trabotti, che dalla città viene in Vespa a trovare l'ormai vecchia suor Emma, alla ricerca di notizie su quel bambino.
Da qui in poi il romanzo procede con una prosa emozionante. Ho letto tantissimo nella mia vita, per diletto, per studio, per professione. Ho ammirato spesso, ho criticato altrettanto, mi sono emozionato poche volte. Qui sì.
Quando leggo un autore esordiente, più che lo stupore per dove ha trovato la storia, mi interessa l'incanto di dove abbia trovato la voce, quel timbro così particolare della prosa che, appena sbocciata, pare già matura.
Così è per le pagina di Martina Merletti, per la gestione sospesa dell'andirivieni di analessi e prolessi che fa del romanzo un puzzle in continua costruzione, con agnitiones credute plausibili e poi ritardate, con quella protasi iniziale che per lunghe pagine sembra non c'entrare nulla con la vita sonnacchiosa di un bar piemontese, e poi si riaffaccia, a pezzettini, per ricomporsi in unità alla fine. Senza strombazzamenti, con quella cortesia tutta piemontese, che rifugge i coup de théâtre e sovente preferisce tacere piuttosto che urlare.
"Ciò che nel silenzio non tace" è un romanzo importante per la storia che racconta e per il modo in cui lo fa.
Trovo, nello stile rispettoso e quasi trattenuto, un non so che di manzoniano.
Mi stupisce che suor Giuseppina, nella relazione delle sue attività al carcere, battuta a macchina nel '46 per il cardinale Fossati e conservata oggi all'Archivio Arcivescovile diocesano, non faccia mai menzione di quello e degli altri bambini che verosimilmente ha salvato. Avrebbe potuto ben farne sfoggio, eppure c'è un bene che evangelicamente va tenuto segreto. Immagino anche per rispetto delle madri e dei padri che quei bambini avranno poi custodito (e il dramma di una verità che, pur nobile, va taciuta, emerge a pag. 248).
Il coraggio del silenzio, la custodia dei destini degli altri, che non appartengono ai salvatori, il pudore di fermarsi un attimo prima, di essere piuttosto reticenti che invadenti, è una lezione manzoniana che fa di questo romanzo d'esordio un romanzo bellissimo.
Rubrica a cura di Stefano Motta