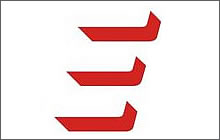LIBRI CHE RIMARRANNO/22: ''Latte e Ghiaccio'' di Stefano Motta

Poiché il popolo è incolto e la memoria può fallare, esistono artifici mnemonici cui aggrapparsi: "Ma con gran pena le reca giù" insegnavano le maestre per ricordare la suddivisione delle Alpi (Marittime, COzie, GRAie ecc.); SIIAAGGL veniva insegnato al popolino, che faticava a ricordarsi tutti e sette i peccati come noi del resto fatichiamo sempre a ricordarci il settimo nano, o il settimo colle di Roma, che ce ne manca sempre uno alla conta (di solito è Gongolo). Superbia, invidia, iracundia, acedia, avaritia, gula, luxuria: e questo è l'ordine che si ritrova, a ritroso, discendendo nei cerchi dell'Inferno. Nella cavea desolata di Cocìto, dove il vento prodotto dalle ali di Lucifero ghiaccia le acque dei fiumi infernali, sono immersi i peggiori di tutti i peccatori: i traditori. Secondo la logica ferrea del contrappasso dantesco il gelo del cuore che in vita li ha spinti a fare del male agli altri li attanaglia ora per intero, lasciando loro libero solo il petto, o il capo, o il solo viso, rivolto verso l'alto con gli occhi sbarrati e le lacrime stesse che, ghiacciandosi senza riuscire a colare lungo le guance, aggiungono pena a pena. Che è difficile provare pietà per i traditori. L'inferno peggiore è perciò di ghiaccio, non di fuoco. In questo inferno ghiacciato si immerge uno scrittore che spesso veniva definito per refuso giornalistico "meratese" e che un po' ha finito per sentirsi "meratese d'adozione". Lo fa in un suo libro che raccoglie due racconti dalle atmosfere dantesche, non tanto e non solo nel titolo, Latte e Ghiaccio (Edizioni del Faro, Trento 2020, pp. 125, Euro12,00), quanto nei titoli dei capitoli interni, che evocano l'iscrizione della porta dantesca: "Per me si va ne la città dolente...".
L'incipit di Ghiaccio contiene in filigrana quell'altro incipit, assai più famoso, del "mezzo del cammin", e fa così:
"Ancora lontano dalla soglia degli anni che secondo il Salmista ci sono dati eppur appesantito da quelli che sinora ho vissuto, mi sono fatto persuaso che la vera felicità nella nostra vita risieda nella capacità, o nel dono che qualcuno ha la grazia di avere, di essere presenti a noi stessi mentre il tempo corre inesorabile, e noi cerchiamo stoltamente di trattenerlo, di precederlo, di comandarlo. Mi guardo indietro e mi accorgo di come davvero la vita dell'uomo sia divisa in due stagioni. Nella prima abbiamo piedi avidi di correre, mani creatrici e occhi che guardano avanti, oltre, bucando le nebbie dei giorni che verranno e credendo, vedendo addirittura, con l'illusa fiducia che solo i giovani hanno, che ci sarà qualcosa di buono. Nella seconda gli occhi si volgono indietro, a raccogliere con rimorso, o rimpianto, o malinconia, le impronte dei passi che abbiamo compiuto, le promesse che abbiamo fatto, quelle che non abbiamo mantenuto, le gioie da cui ci siamo tenuti a distanza e che ora ci mancano. Dio, quanto ci mancano! Non so di preciso quando sono diventato uomo, quando ho valicato la soglia che mi ha consegnato alla maturità. O alla vecchiaia. Se devo scegliere, scelgo l'estate del 1671. Avevo trentatré anni, l'età in cui Nostro Signore discese nell'Abisso, quando la voce di ghiaccio dell'abisso di Moncòden parlo ai miei orecchi. Nostro Signore ne risalì dopo tre giorni. Io sono ancora là."
Stefano Motta