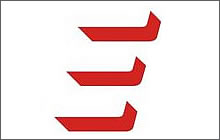LIBRI CHE RIMARRANNO/16: ''Nella pietra e nel sangue'' di Gabriele Dadati

Se sei figlio di Enrico VI e Costanza d'Altavilla e nipote di quel Barbarossa, va da sé che ti chiamerai Federico.
Se parli sei lingue, tedesco, latino, siciliano, francese, greco e arabo, se vinci una crociata senza spargere un goccio di sangue (e il papa per questo paradossalmente si adira) è naturale che ti chiamino "stupor mundi", meraviglia del mondo.
Alla corte di Federico II, che elesse l'Italia Meridionale come sede del suo potere e ne fece la culla di tutto quanto di bello la letteratura europea poi produsse, nacque il siciliano illustre e i primi testi letterari italiani. Poeta lui stesso, incoraggiò i dignitari della sua corte a comporre, e la sua vita trascorse tra il dispiegarsi dei versi e il farsi delle decisioni, tra la musica della ghironda che copriva lo stridio delle spade che venivano affilate.
Il più grande dei poeti che cantarono in siciliano illustre fu il suo logoteta, Petrus de Vinea, quel Pier delle Vigne che Dante colloca al XIII dell'Inferno, nella selva dei suicidi, uccisosi per sfuggire all'onta dell'accusa di tradimento con la quale era stato estromesso dalla Curia imperiale.
Davvero tradì Federico?
E se sì, perché dopo averlo fatto accecare, l'imperatore lo lasciò libero e in vita, a Pisa, nonostante tutti i segreti che di certo conosceva?
Davvero si sarebbe ucciso come racconta Boccaccio?
Nelle "Esposizioni sopra la Comedìa di Dante" si legge infatti che "essendo in Pisa avvenne un giorno che egli in tanto furor s'accese che disiderò di morire" e chiese perciò al fanciullo che gli faceva da guida dove fosse la chiesa a cui era vicini: "indirizzami verso di essa", gli disse. "Il che come il fanciullo fatto ebbe, esso, sospinto da furioso impeto, messosi il capo inanzi a guisa d'un montone, con quel corso che più impetuoso poté, corse a ferire col capo nel muro della chiesa, e in quello ferì di tanta forza che la testa gli si spezò e sparseglisi il cerebro, uscito dal luogo suo, e quivi cadde morto".
Davvero è andata così? E cosa ci faceva a Pisa?
Si rimane esterrefatti dai particolari grandguignoleschi della fine di un personaggio così raffinato, soprattutto se decisi o favoriti da quell'imperatore così colto, e si condivide col protagonista del romanzo di Gabriele Dadati, "Nella pietra e nel sangue" (Baldini e Castoldi, 2020, pp. 287) la ricerca e lo smarrimento.
Nei capitoli si intrecciano due storie, quella di Pietro della Vigna e quello di Dario Arata, giovane ricercatore universitario impegnato nella preparazione di un suo contributo a un convegno dantesco.
La storia c'è tutta. La narrazione ogni tanto inciampa. Capita di voler scorrere velocemente alcune pagine dei capitoli medievali per tornare ai punti lasciati in sospeso da quelli ambientati ai nostri giorni, e purtroppo anche viceversa. C'è un ritmo singhiozzante negli uni come negli altri, rallentato da digressioni che appaiono quasi autobiografiche e che aggiungono solo pagine e non pàthos al romanzo. La spannung del colloquio con la Madame Legrand al Collège de France fa molto colloquio tra Langdon e Sophie e sir Leigh Teabing nel "Codice da Vinci".
Eppure.
Eppure c'è qualcosa di dantesco nelle pagine di Dadati: l'attacco del primo capitolo vale da solo la lettura. Si poteva fare di meglio e potrà sicuramente fare di meglio in futuro. Intanto ha fatto questo, e non è comunque male.
Stefano Motta