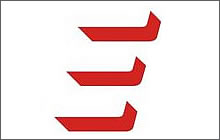LIBRI CHE RIMARRANNO/13: ''Bianco come Dio'', di Nicolò Govoni

Perché un libro non è un banchetto per la raccolta fondi, né un'omelia, né tantomeno un documentario sulle condizioni sfortunate dei poveretti del Sud del Mondo: un libro è un libro, e vive di sue proprie logiche. Altrimenti finisce che uno lo compera perché sulla copertina c'è il bollino che dice che i proventi verranno devoluti in beneficenza, e poi lo lascia lì sullo scaffale a prendere polvere o a sorreggere altri libri. E l'autore non se ne fa nulla dei 17 euro che tu hai speso per comperare la tua copia, se non sei entrato nella sua storia.
Perché questo avvenga, però, la storia deve essere scritta bene.
Ci sono capolavori di questo genere: è inarrivabile "La città della gioia", di Dominique Lapierre. E dietro c'è il nulla o quasi di una letteratura presto divenuta di genere.
La storia c'è, in "Bianco come Dio", di Nicolò Govoni (Rizzoli, pagg. 220, Euro 17.00), ed è quella di un giovane ventenne, partito come "volonturista" alla volta dell'India e rimasto imprigionato tra le braccia dei bambini dell'orfanatrofio di Dayavu Home.
La narrazione c'è: il racconto nasce prima su facebook, poi su un blog, poi tramite un'autopubblicazione (perché mica tutti i libri stampati da sé sono vanity publishing), fin quando Rizzoli non si accorge del potenziale e non decide di investire su questo libro.
Anche la retorica c'è. Ci sono frasi che potrebbero essere espunte e scritte sui manifesti, o citate come slogan impegnati: "Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per aggiustarlo, hai due possibilità: ti rassegni a vivere una vita che non è la tua, o ti rimbocchi le maniche e provi a migliorare le cose, un bambino alla volta". Oppure: "Non torno, mamma. I bambini sono la fine del mondo. Non voglio fare la predica a nessuno, solo dirti che non posso tornare. Tranquilla per me, non sono mai stato più felice". Ma è una retorica cui non si deve per forza fare la tara con la disillusione degli adulti: la si assapora invece con invidia per gli stessi slanci giovanili che magari qualcuno di noi ha condiviso, nel suo piccolo.
Per anni, da giovane, ho dedicato il mio intero mese d'agosto come volontario al Cottolengo di Torino, e so che molti dei miei lettori hanno altrettante e forse ancora più significative esperienze che potrebbero condividere. Ho letto questo libro immedesimandomi nel padre di Nicolò, quando sbarca stranito e timido nel villaggio indiano, al seguito del figlio. E ho avuto invidia del me che ero da giovane, e dei tanti giovani che nel mondo stanno cercando di raddrizzare le storture che noi adulti non siamo ancora riusciti a correggere. Quando non siamo stati noi stessi a provocarle.
Anche la causa benefica c'è: acquistando questo libro si contribuisce alla costruzione di una biblioteca in India.
Ma è anzitutto scritto bene: puoi avere la storia più generosa ed edificante del mondo, ma se la scrivi male non serve a niente. Il bene bisogna farlo bene, e anche raccontarlo bene.
Stefano Motta