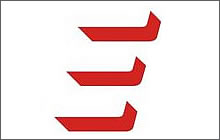LIBRI CHE RIMARRANNO/3: ''Natale del 1833'' di Mario Pomilio e ''Oratorio di Natale'' di Göran Tunström
"I libri parlano sempre di altri libri", diceva Umberto Eco, ma i libri parlano anche con gli altri libri, magari quelli che stanno loro accanto.
Ho un criterio tutto mio per ordinare la mia biblioteca e non saprei esplicitarlo in una regola. "A caso", forse. Quella di casa è una biblioteca non di accumulo né solo di lavoro. Ci sono opere e volumi che hanno un posto specifico e che posso recuperare alla cieca come farebbe un dentista coi ferri del mestiere e poi ci sono tutti gli altri, la più parte, disposti come viene.
Un po' per autore, un po' per casa editrice, un po' per argomento, un po' per colore, anche un po' per dimensioni, un po' per lettore. Quella di casa è una biblioteca di ricerca, e di scoperta.
Così capita che dovendo tenere una conferenza manzoniana la scorsa settimana abbia ripescato quel bellissimo romanzo di Mario Pomilio che racconta del Natale del 1833, in casa Manzoni, il giorno in cui morì Enrichetta Blondel. E accanto, messo lì per una suggestione non difficile da cogliere, un romanzo svedese degli anni Ottanta, giunto in Italia a metà dei Novanta per merito di quella geniale ed elegantissima casa editrice che è Iperborea.
 Due romanzi diversissimi, accomunati dal titolo, che negli anni passati l'uno accanto all'altro sugli scaffali del mio studio sono divenuti amici, secondo me. E si sono scambiati emozioni e atmosfere.
Due romanzi diversissimi, accomunati dal titolo, che negli anni passati l'uno accanto all'altro sugli scaffali del mio studio sono divenuti amici, secondo me. E si sono scambiati emozioni e atmosfere.
Nel "Natale del 1833" Pomilio prende l'avvio dalla lirica incompiuta di Manzoni, quello che avrebbe potuto essere il tredicesimo degli altrettanto incompiuti Inni Sacri, scritto in morte della moglie Enrichetta e lasciato "non finito". È Virgilio, nel libro sesto dell'Eneide, a raccontare dello strazio impotente che fece cadere lo scalpello di mano a Dedalo, scultore abilissimo ma incapace di istoriare la morte del figlio Icaro, e sono le stesse mani di Manzoni a cascare sui fogli perlopiù bianchi, con qualche verso vergato nervosamente e a spezzoni, incapaci di scrivere di quel dolore tanto più assurdo quanto così cronologicamente impietoso. Le mani che narreranno di Renzo e Lucia e Gertrude e Cecilia non trovano forza e parole. "Perché il dolore nel mondo nonostante Dio?".
Pomilio lavora sulle uniche fonti dirette in cui Manzoni accenna alla scomparsa della moglie e della figlia primogenita, che la segue di lì a poco, quelle del 19 febbraio, del 31 ottobre, del 5 e 23 dicembre 1834) e sui due abbozzi autografi del "Natale del 1833". Il resto del romanzo è la capacità di uno scrittore di leggere tra le pieghe dell'animo di un altro scrittore, ed è questo che rende il romanzo un pugno dritto al cuore.
Ci sono Dante e Petrarca, invece, nell'"Oratorio di Natale" di Göran Tunström. E Mark Twain, anche. E la musica di Bach, naturalmente. La storia è quella di Victor Nordensson, musicista di fama internazionale, che ritorna, dopo molti anni e innumerevoli successi in giro per il mondo, a Sunne, il paesino svedese dove è nato. Ci torna per dirigere, lui!, l'Oratorio di Natale di Bach con un'orchestra di dilettanti.
Ci torna per saldare un filo suggestivo che si era spezzato cinquant'anni prima, il progetto dello stesso oratorio sognato da Solveig, "l'americana", che era passata in quel borgo spargendo attorno a sé gioia, carezze, musica e sensualità, e se n'era andata con una fine inattesa e tragica nelle sue dinamiche che parrebbero persin comiche: muore a pagina 24, lanciata in bicicletta lungo un pendio pratoso, i freni che saltano, la catena che si inceppa, la caduta nel pieno di una piccola mandria di vacche, e i loro zoccoli che fanno il resto.
Muore a pagina 24 eppure vive per tutto il romanzo.
E io penso che Enrichetta e Solveig si parlino ogni tanto da quei due libri messi accanto, e si raccontino di come i loro mariti abbiano cercato di annegare nell'arte il dolore, prima di capire che l'arte poteva essere una finestra aperta e non una lastra tombale sotto cui rinchiudersi. Ed Enrichetta racconta di quando Alessandro le aveva chiesto di suonare il pianoforte, mentre lui cercava di scrivere l'ode in morte di Napoleone, e Solveig le racconta di quanto Aron fosse schivo e di come lei gli abbia insegnato la bellezza di baciarsi alla luce del sole. O viceversa, anche.
"La vita contiene molte cose incomprensibili - ha detto Tunström in un'intervista - che accettiamo e che ci rendono curiosi. L'arte non deve essere una conferma ma una porta su un mondo nuovo."
La scrittura, o la musica (e quanta musica c'è nelle parole di Manzoni), o la pittura, la scultura, la danza, l'arte che ciascuno di noi coltiva, disordinata magari come disordinati sono i miei libri: loro ci salvano da questo Natale 2020 così strano, in cui tutti cerchiamo risposte non sul virus, ma sulla vita.
Nessuno di noi riesce a mettere una parola compiuta, poiché di ciò che ci sta colpendo non abbiamo inteso il principio e non riusciamo ancora a vedere la fine. Ma è in questo "non finito" che abita l'arte. Nelle Pietà non-finite di Michelangelo come nel "Natale 1833" di Manzoni e nell'Oratorio di Bach che impiega tre generazioni prima di essere cantato a Sunne.
Ci sono pagine fatte di parole non dette. E certi fallimenti non sono forse frammenti copiati dal nostro cuore?
Ho un criterio tutto mio per ordinare la mia biblioteca e non saprei esplicitarlo in una regola. "A caso", forse. Quella di casa è una biblioteca non di accumulo né solo di lavoro. Ci sono opere e volumi che hanno un posto specifico e che posso recuperare alla cieca come farebbe un dentista coi ferri del mestiere e poi ci sono tutti gli altri, la più parte, disposti come viene.
Un po' per autore, un po' per casa editrice, un po' per argomento, un po' per colore, anche un po' per dimensioni, un po' per lettore. Quella di casa è una biblioteca di ricerca, e di scoperta.
Così capita che dovendo tenere una conferenza manzoniana la scorsa settimana abbia ripescato quel bellissimo romanzo di Mario Pomilio che racconta del Natale del 1833, in casa Manzoni, il giorno in cui morì Enrichetta Blondel. E accanto, messo lì per una suggestione non difficile da cogliere, un romanzo svedese degli anni Ottanta, giunto in Italia a metà dei Novanta per merito di quella geniale ed elegantissima casa editrice che è Iperborea.

Nel "Natale del 1833" Pomilio prende l'avvio dalla lirica incompiuta di Manzoni, quello che avrebbe potuto essere il tredicesimo degli altrettanto incompiuti Inni Sacri, scritto in morte della moglie Enrichetta e lasciato "non finito". È Virgilio, nel libro sesto dell'Eneide, a raccontare dello strazio impotente che fece cadere lo scalpello di mano a Dedalo, scultore abilissimo ma incapace di istoriare la morte del figlio Icaro, e sono le stesse mani di Manzoni a cascare sui fogli perlopiù bianchi, con qualche verso vergato nervosamente e a spezzoni, incapaci di scrivere di quel dolore tanto più assurdo quanto così cronologicamente impietoso. Le mani che narreranno di Renzo e Lucia e Gertrude e Cecilia non trovano forza e parole. "Perché il dolore nel mondo nonostante Dio?".
Pomilio lavora sulle uniche fonti dirette in cui Manzoni accenna alla scomparsa della moglie e della figlia primogenita, che la segue di lì a poco, quelle del 19 febbraio, del 31 ottobre, del 5 e 23 dicembre 1834) e sui due abbozzi autografi del "Natale del 1833". Il resto del romanzo è la capacità di uno scrittore di leggere tra le pieghe dell'animo di un altro scrittore, ed è questo che rende il romanzo un pugno dritto al cuore.
Ci sono Dante e Petrarca, invece, nell'"Oratorio di Natale" di Göran Tunström. E Mark Twain, anche. E la musica di Bach, naturalmente. La storia è quella di Victor Nordensson, musicista di fama internazionale, che ritorna, dopo molti anni e innumerevoli successi in giro per il mondo, a Sunne, il paesino svedese dove è nato. Ci torna per dirigere, lui!, l'Oratorio di Natale di Bach con un'orchestra di dilettanti.
Ci torna per saldare un filo suggestivo che si era spezzato cinquant'anni prima, il progetto dello stesso oratorio sognato da Solveig, "l'americana", che era passata in quel borgo spargendo attorno a sé gioia, carezze, musica e sensualità, e se n'era andata con una fine inattesa e tragica nelle sue dinamiche che parrebbero persin comiche: muore a pagina 24, lanciata in bicicletta lungo un pendio pratoso, i freni che saltano, la catena che si inceppa, la caduta nel pieno di una piccola mandria di vacche, e i loro zoccoli che fanno il resto.
Muore a pagina 24 eppure vive per tutto il romanzo.
E io penso che Enrichetta e Solveig si parlino ogni tanto da quei due libri messi accanto, e si raccontino di come i loro mariti abbiano cercato di annegare nell'arte il dolore, prima di capire che l'arte poteva essere una finestra aperta e non una lastra tombale sotto cui rinchiudersi. Ed Enrichetta racconta di quando Alessandro le aveva chiesto di suonare il pianoforte, mentre lui cercava di scrivere l'ode in morte di Napoleone, e Solveig le racconta di quanto Aron fosse schivo e di come lei gli abbia insegnato la bellezza di baciarsi alla luce del sole. O viceversa, anche.
"La vita contiene molte cose incomprensibili - ha detto Tunström in un'intervista - che accettiamo e che ci rendono curiosi. L'arte non deve essere una conferma ma una porta su un mondo nuovo."
La scrittura, o la musica (e quanta musica c'è nelle parole di Manzoni), o la pittura, la scultura, la danza, l'arte che ciascuno di noi coltiva, disordinata magari come disordinati sono i miei libri: loro ci salvano da questo Natale 2020 così strano, in cui tutti cerchiamo risposte non sul virus, ma sulla vita.
Nessuno di noi riesce a mettere una parola compiuta, poiché di ciò che ci sta colpendo non abbiamo inteso il principio e non riusciamo ancora a vedere la fine. Ma è in questo "non finito" che abita l'arte. Nelle Pietà non-finite di Michelangelo come nel "Natale 1833" di Manzoni e nell'Oratorio di Bach che impiega tre generazioni prima di essere cantato a Sunne.
Ci sono pagine fatte di parole non dette. E certi fallimenti non sono forse frammenti copiati dal nostro cuore?
Stefano Motta